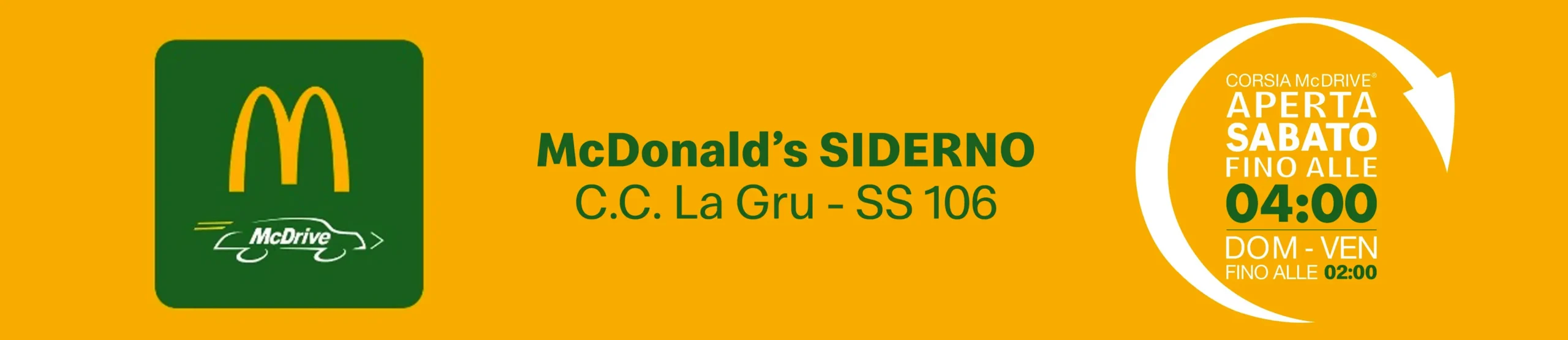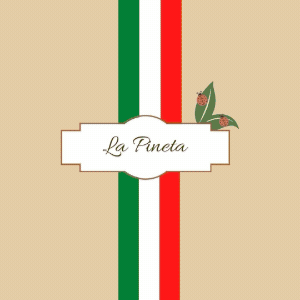di Mario Staglianò (foto fonte avvenire.it)
Periodicamente ci si interroga sul disagio giovanile. Accade, solitamente, in occasione di eventi traumatici collettivi come la pandemia (e si parla allora di una generazione intera, si citano statistiche, per poi il giorno dopo passare ad altro) o individuali come un qualunque massacro in cui a prendere il sopravvento sono le curiosità morbose sul “perché” (….era così un bravo ragazzo!), e le indebite generalizzazioni (dimenticandosi che di quel ragazzo/a, della sua costellazione familiare, della sua storia, non sappiamo nulla). Il fatto è che poniamo le domande sbagliate nei momenti sbagliati: ciò che si fa visibile nell’emergenza è profondamente radicato in strutture di senso ed è quel senso che dovrebbe essere oggetto dell’interrogazione.Il termine disagio indica una situazione di distanza, di non prossimità, che genera sconforto. Questa evocazione della distanza, e del correlato malessere, è particolarmente appropriata al cosiddetto disagio giovanile contemporaneo: non trovarsi prossimi ad alcunché – a un mondo, a un altro soggetto. Non sento nulla e nessuno vicino, non c’è nulla e nessuno che mi tocchi: non c’è contatto, non c’è connessione. Una connessione profonda, non quella immaginaria di un occhio disincarnato. Questo aspetto del disagio, che è il sentirsi sconnessi, isolati, è allora l’isolamento di una società che ha fatto dell’individuo e del proprio successo l’unico Valore.
La trinità comandamentaria del nostro tempo è costituita da tre claim pubblicitari: Just do it; Nothing is impossible; Tutto intorno a te. A costituirne il senso comune, l’imperativo fondamentale di questa società neoliberale degli individui e della performance: Sii imprenditore di te stesso. Just do it è l’imperativo della Nike: devi solo farlo. L’unica cosa che devi fare è farlo perché tutto è lì, a tua disposizione. Tutto è possibile. Come dice il secondo claim, quello di Adidas, antagonista della Nike:Nothing is impossible. Niente è impossibile, appunto. Tutto è a tua disposizione. Tu vivi immerso in un oceano di possibilità, nulla che tu non possa conseguire: dipende solo da te. Perché, come dice il terzo claim più volte usato negli anni, ”Tutto è intorno a te”. Prenditelo!. Sei l’unico responsabile e, se non ce la fai, sei tu quello da biasimare. Sei tu e solo tu il vincente, sei tu e solo tu il perdente.
In questo contesto si colloca l’ideologia del merito. Sei chiamato a essere continuamente all’altezza di standard performativi che ti sovrastano, ingiunzioni che ti soverchiano, in ogni ambito della tua vita. Eccellere in qualsiasi campo, essere all’altezza di standard in base ai quali sei scrutato, misurato, giudicato. Nella società normata dalla possibilità e non più dal divieto (dall’Edipo), l’individuo è sollecitato non all’obbedienza, ma all’iniziativa, per essere all’altezza. Non è più questione di colpa, legata alla legge che vieta – Edipo che si punisce per aver infranto il tabù – ma di vergogna, legata al profilo sociale – Narciso che non riesce a essere all’altezza del suo progetto, del proprio Io Ideale.
Possiamo osservare la presenza ubiquitaria della nuova norma sociale performativa nei due luoghi dove gli adolescenti passano più tempo: la scuola e la famiglia. Ansia, panico, fobia sociale ma, anche, ritiro sociale, disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo. Eventi psichici estremamente diffusi e sempre più comunemente osservabili da chi insegna nelle scuole. Negli ultimi anni, in molte scuole, studenti e studentesse hanno preso parola fino a occupare il proprio istituto, in relazione a questo contagio di sofferenza psichica, mettendo a tema politico questa questione apparentemente privata. Contagio, dico, perché i sintomi di una sofferenza sono sempre in relazione con una dimensione comune, che precede ogni individuo, proprio come il linguaggio – che si trasmette come un virus, appunto.
La fragilità è una condizione ampiamente rivendicata da studenti e studentesse. In una lettera pubblica, gli studenti del liceo Berchet di Milano – dopo l’abbandono degli studi da parte di oltre cinquanta ragazzi e ragazze, che non era per loro da ricondurre agli effetti della pandemia e della didattica a distanza come invece era stato fatto – avevano scritto: “Ciò su cui cerchiamo di porre l’attenzione è solo il necessario riconoscimento di una dignità della fragilità”. Questa rivendicazione era strettamente connessa alla richiesta di una “relazione empatica tra studenti e professori”, intendendo la scuola come “non uno sterile trasferimento di nozioni, bensì un luogo e un tempo di cura dei rapporti umani in chiave formativa”.
Se educazione è lo spazio relazionale in cui formare il proprio sé, allora essa è prima di tutto sperimentazione, apertura, ricerca. Non è conseguire qualcosa, non è produrre sé come un’eccellenza, essere imprenditori di sé all’altezza di un modello e di uno standard valutativo. Si diventa adulti grazie a processi di interruzione, necessaria per potersi ridefinire in relazione agli altri. Ma in un percorso orientato allo scopo previsto e centrato sull’accumulazione di competenze, non c’è spazio per quelle interruzioni e quelle sospensioni necessarie per una crescita personale.
Margaret Thatcher disse che “la società non esiste, esistono solo gli individui”, ma aggiunse: “e le loro famiglie”. In una società frammentata, dove i legami sociali e comunitari si dissolvono, la famiglia è un grande individuo, il solo luogo di consistenza identitaria legittima, dove le relazioni sono principalmente marcate dall’affetto. Famiglia affettiva significa una famiglia che ha come suo centro la costruzione di relazioni positive e dialogiche prima che la posizione di regole e la trasmissione di valori: ciò che appare come un importo assolutamente positivo rispetto alla famiglia normativa di un tempo, dove la Legge del Padre imperversava a suon di divieti e punizioni, all’interno di un mondo fatto di confini stabiliti e identità stabili. Ma se pensiamo questa trasformazione all’interno della società performativa troveremo in questa trasformazione alcuni problemi di fondo: il punto critico, in parallelo al sovrainvestimento di aspettative, è che il progetto fondamentale è la costruzione della “felicità” del bambino, e che dall’orizzonte educativo sono bandite le emozioni negative.
Nella società del Narciso, l’obiettivo è che il bambino sia una persona solare, come incautamente si usa dire, dimenticandosi che l’umano è fatto anche d’ombra e quell’ombra deve poterla esprimere, articolare, darle senso. Invece sperimentare sentimenti negativi è considerato, nel modello pedagogico della famiglia affettiva, esso stesso un fallimento e il bambino è tenuto lontano da ogni possibile frustrazione o fonte di sofferenza. Via ogni tristezza che corrughi il volto solare, che emana la luce che rischiara il sistema-famiglia. A dover essere protetto dal dolore non è solo il bambino, ma tutto il contesto del sistema-famiglia, che su quella positività investe ogni risorsa, e di fronte a tristezza e sofferenza si scopre fragile, incapace di sopportarle. Tutto ciò che ha a che fare con la finitezza e il limite, e dunque con la vulnerabilità e la fragilità, viene messo ai margini.
In questo sistema-famiglia il figlio concentra su di sé aspettative e diventa oggetto di proiezioni (narcisistiche) del genitore il quale finisce per considerarlo una propria estensione. A orientare tutta l’azione educativa – ciò per cui si può parlare a buon diritto di “narcisismo familiare” – è il progetto della realizzazione sociale del figlio, del suo successo, mettendogli a disposizione ogni risorsa possibile. E se il figlio è come un’estensione narcisistica del genitore, il quale non può accettare di fallire in quanto “buon genitore”, non può e non deve deludere le aspettative in lui riposte. Deve corrispondere a quelle attese, deve essere la testimonianza incarnata dell’esser stato buon genitore dei genitori. Di fatto non esiste come un sé autonomo ma è uno specchio del genitore. Al figlio è implicitamente richiesto di far sentire agli adulti, narcisisticamente fragili, che tutto va bene. E quello che non possono dire, alla fine, lo dice il corpo, con le sue varie forme di sofferenza. Quelli che lo psicoanalista Massimo Ammaniti chiama “genitori elicotteri”, allora – adulti ancora adolescenti che tengono sotto controllo spasmodico il figlio, facendo da ostacolo al suo naturale bisogno di autonomia –, sono genitori che non vogliono che il figlio esca dal proprio sogno ma che lo compia così come previsto e progettato. E dev’essere un percorso senza ombre, dove tristezza, ansia, paure sono accidenti da cancellare e bandire.
Un episodio della serie tv distopica Black mirror, Arkangel, raccontava bene questo legame stretto tra ipercontrollo e evitamento di ogni negatività possibile, dove Arkangel era il sistema di controllo neurale impiantato in una bambina che permetteva alla madre di avere ogni informazione su di lei, vedendo in ogni momento quel che lei vedeva, e impedendole al contempo di vedere situazioni per lei stressanti, che fossero violente o spaventose; cosa che rendeva la bambina non solo incompetente nella gestione delle proprie emozioni, ma radicalmente negata nella sua autonomia, nella sua identità, nella sua libertà e responsabilità, insomma nella sua dimensione di soggetto. Nella nostra realtà non c’è un chip neurale che permetta di vedere attraverso gli occhi di un figlio ma ci sono i telefoni che del figlio registrano la posizione e una moltiplicazione di sistemi di controllo che pongono la questione negli stessi termini.