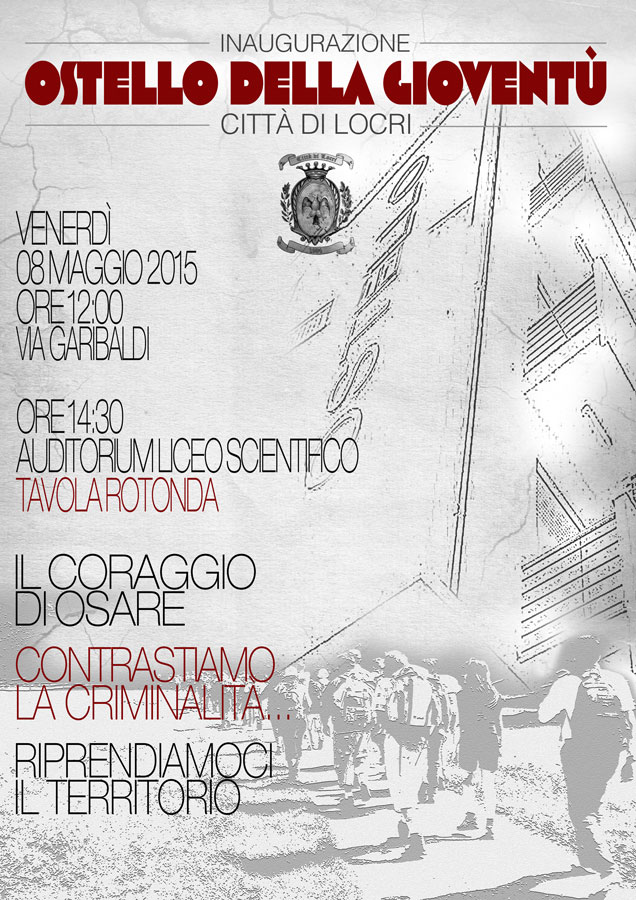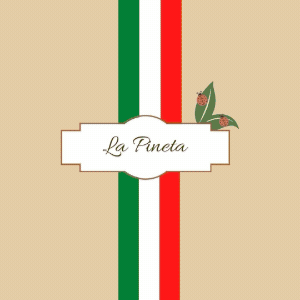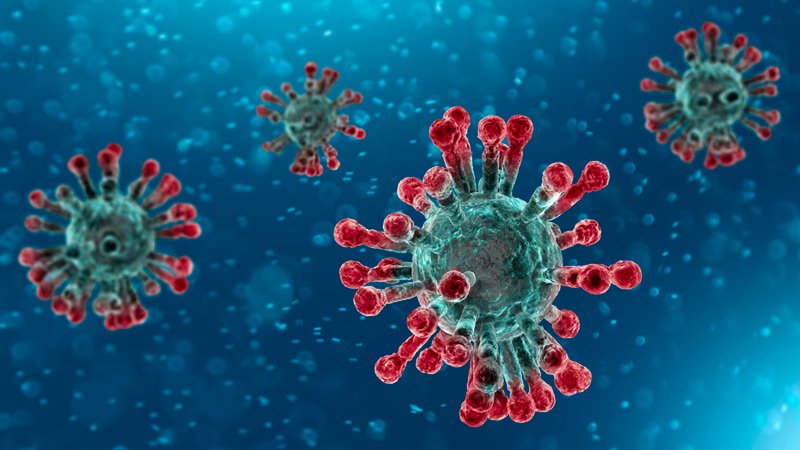Cinquanta milioni di anni. Eccola! E’ qui, nelle mie mani: una conchiglia fossile, una pagina della genesi della terra e dell’universo scritta dalle potenti forze della natura assai prima che l’uomo facesse la sua comparsa. Guardandola mi par di sentire che è sempre esistita, e in questo suo essere materia priva del segno delle vitalità caduche si può compiere un viaggio a ritroso negli infiniti meandri del tempo, come un viandante senza età che per quanto s’affanni non giungerà mai al principio inseguito.
{loadposition articolointerno, rounded}
Non è capitata nell’aratura delle reti gittate profonde dai pescatori, e neppure chi ama andare sott’acqua, tingendosi di luce tremula e striature azzurrine, l’ha potuta sottrarre al fondo fangoso, disteso all’ombra d’un antro marino. E’ figlia del moto prolifero del mare, ma non di quello che oggi ci appare nell’immensità cerula delle giornate solari, o nel fustigare rovinosamente la costa sotto nuvole estese, basse e oscure, ovvero il Mediterraneo primigenio di civiltà feconde divenuto tomba dell’umanità perduta. Mi è stata donata, oppure mi ha scelto avvertendo il mio sguardo stupito e ammirato, nel luogo in cui si è rivelata come schiusa dall’incanto di uno scrigno misterioso e segreto; dove, zappando la vigna crescono vigorosi i sarmenti al suono rotolante di certe pietre che hanno nell’imo la nitida impronta di un pesce, di una stella marina, il guscio varioforme di un mollusco, i resti di organismi fissati in eterno nell’ultimo spasmo di vita; e scavando nel ventre di un clivo una fresca cantina per spandere i tenaci primitivi umori e profumi salmastri sotterra nel fermento del buon vino degli allegri convivi, si scopre un giacimento di conchiglie fossili, un cimitero preistorico eletto, posto a decine e decine di chilometri dal mare, sulle alte colline che preludono alle vette, ai pianori, ai laghi e alle selve intricate della Grande Sila.
Sicuramente, essa c’era più di cinquanta milioni di anni fa, quando un globo d’acqua in sommovimento, senza isole e continenti che potessero sfrangiare le sue onde inesauste, vagava inquieto nel cosmo degli abissi siderali e delle galassie stellari; quando le terre sommerse decisero di levarsi erette per incontrare il sole e la luna e respirare gli effluvi dei cieli, e partorire le nuove vite primigenie da cui presero corpo gli animali e le piante e il genere umano privo di quelle lesioni del cervello, di quelle diversità mentali che lo portano a confliggere con se stesso, disperdendo l’essenza conviviale delle civiltà dei popoli volte ad un futuro di pace. Ha in sé le aurore e i tramonti degli eoni travagliati del tempo e al suo cospetto le nostre vite frangono nel volo effimero d’una farfalla, nel fuggente spazio d’un battito d’ali, d’un respiro che non lascia memorie di gioie e dolori.
Questo grazioso ventaglio perlato dai canali ritorti che coprono il palmo della mia mano, non l’ho voluto ripulire, spogliare dei suoi ricordi, degli elementi che l’avvolsero nel mondo sommerso. Mostra il colore smunto e il luccichio delle polveri rilasciate dalle sabbie che stratificarono velo su velo nelle quieti che seguirono all’agitazione delle tempeste immani. Sul guscio vi trovò posto un lavorio lunghissimo, di estenuante durata, che stese gallerie e labirinti, orme e ramificazioni come varici di altre esistenze trascorse, mentre i nautili estinti e i lepadi gli facevano corona e i lenti murici a frotte muovevano attorno sospinti dalle danze incessanti delle correnti, sulle colline scoscese e gli aspri promontori sommersi, ammantati di poriferi e madrepore, delle gamme inimmaginabili delle cromie e sfumature negli sconfinati panorami primordiali.
Ora è tra le cose che mi sono più care, nella vecchia vetrina che fu nella dote che mio padre portò quando sposò mia madre. Attraverso quei vetri rivedo riflessi i miei anni assieme alla conchiglia riammessa ad un’altra vita.
Di Francesco Tuccio *