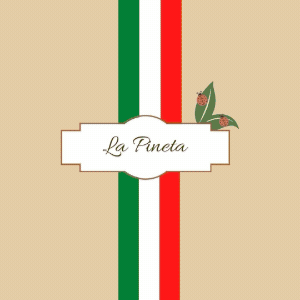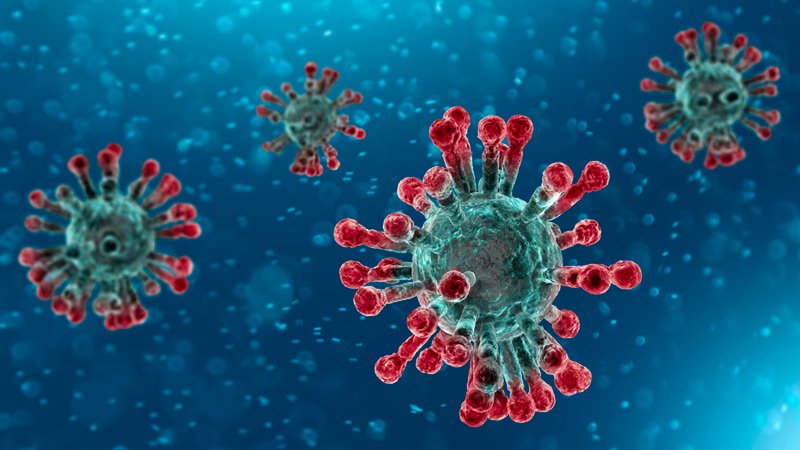di Gianluca Albanese
LOCRI – Dietro la sfuriata del giudice Sicuro, che stamani ha concluso immediatamente l’udienza del processo “Recupero-Bene Comune” perché nessuno dei testimoni attesi per l’escussione era presente, non c’è solo l’applauso dei detenuti: traspare soprattutto umanità.
Umano è il gesto del magistrato che s’arrabbia per il tempo e i soldi pubblici sperperati per un’escussione che non ha avuto luogo, per le giustificazioni addotte dai testimoni giudicate incongrue e, per usare le parole del presidente “Per rispetto delle ottanta persone presenti”. Già, il rispetto. Che bello sentire richiamare questo nobile principio cardine dell’umana convivenza in un’aula di tribunale. Rispetto per tutti, indipendentemente dai ruoli, dai mestieri, dalle condizioni personali. Rispetto e basta. Chi frequenta la Corte d’Assise avrà avuto modo di apprezzare la conduzione delle udienze da parte del giudice siciliano Alfredo Sicuro. Il suo collega Gianrico Carofiglio, nelle vesti di scrittore di legal-thriller con protagonista il celeberrimo avvocato Guido Guerrieri lo descriverebbe in maniera lusinghiera, perfino mediante i pensieri in libertà del professionista barese con la passione per il pugilato. Ma oggi il protagonista non è il giudice, nemmeno il Pm. Oggi la cronaca non si sofferma sulle parole dei testimoni, sulla loro voce a volte tremante dopo aver letto la formula del giuramento stampata su un cartoncino plastificato. Oggi non si parla dei principi del foro e dei loro controesami, nemmeno delle loro giovani colleghe “in tiro” che qualche sguardo lo catturano sempre; neppure dei giovani praticanti seduti sulla panchina obliqua con la mente e il cuore ancora rivolti ai banchi d’università. Oggi si parla di chi il processo non lo vive da semplice spettatore, perché ha un familiare nella “gabbia” dai vetri blindati. La logistica e i costumi della giustizia penale sembrano quasi voler infliggere qualche punizione accessoria a chi ha un congiunto in carcere. Non importa se sia ancora in attesa di giudizio, se sia un vero delinquente o vittima di qualche errore che solo un bravo avvocato sarà in grado di scoprire per farlo uscire di galera. No, le regole valgono per tutti. E allora i “parenti”, che già sopportano ore e ore di attesa in qualsiasi condizione climatica per andare a trovare i propri congiunti in carcere, magari non fanno nemmeno più caso al loro ingresso separato, allo spazio che spesso li contiene a stento, alle due-tre sedie che si concedono alle donne anziane mentre gli altri seguono in piedi udienze di mattinate o pomeriggi interi. Non fanno caso nemmeno alla disposizione dei tavoli, che sembra fatta apposta affinché quelli che stanno al di là del parapetto (avvocati, giornalisti) diano loro le spalle. Sono lì, in piedi, con l’orecchio teso all’escussione dei testimoni, e uno sguardo a chi, dentro la “gabbia” fa di tutto per mostrarsi forte e sereno, anche quando non lo è. Sono lì in attesa che ai propri cari scappi la pipì, per farsi accompagnare alla toilette con una catena e le manette ai polsi. In quei dieci metri di percorso tra la cella e i servizi igienici c’è il senso di una giornata per i familiari dei detenuti: un attimo per un saluto, un occhiolino, o semplicemente uno sguardo languido, ostentatamente fiero o, più probabilmente triste. Avrà pensato anche a loro il giudice dopo aver invocato rispetto per i presenti. Lui che quei volti se il trova davanti ad ogni udienza. Lui che un giorno dovrà giudicare chi sarà colpevole e chi sarà innocente. Lui e tutti gli uomini e le donne di buonsenso. “Se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo”.