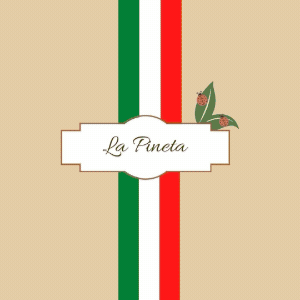di Francesco Tuccio (ph. Mimmo Paparo)
Il palazzo era grande, un gigante di pietra morente. Tre piani alti, affacciati su una delle piazze del paese che a Filomena apparivano opprimenti, immersi com’erano nel buio più fitto. Le porte, le finestre e i balconi erano chiusi come se davanti battesse inferocita la tempesta. Vi regnava sovrano un logoro silenzio stantio di muffe e di ragnatele, e un polverio minuto stratificava, velo su velo, laddove posarono mani delicate e gentili, passi di danza e fruscii setosi di vesti pieghettate sugli impiantiti marmorei, le turbi e i tremori dei recessi della carne, i sospiri profondi nelle alcove segrete, i comandi imperiosi alla servitù dimessa.
{loadposition articolointerno, rounded}
La scalinata monumentale non risuonava più degli affanni, delle voci grevi e delle processioni della povera gente implorante che scandivano incessanti le ore, pareva avvinghiata alle vertigini della solitudine. Solo i topi e i tarli evocavano gli inquieti spettri aviti appesi nelle cornici, a cui rispondevano le trasparenti nudità delle divinità fuggenti, affrescate sulle pareti e i soffitti dorati. Il disfacimento addensava un acre odore di chiuso, custodito come le ricchezze recondite del tempo passato.
La gente, dimentica di ogni fedele deferenza, guardava all’edificio con raggelato distacco, ma le piante erratiche, di stagione in stagione, si rinnovavano pietose nelle fessure diramate come le varici del dramma che infieriva sui muri, i davanzali, le balconate e i cornicioni. Al posto dei fregi del casato trionfavano grasse le ortiche, cosparse di peli urticanti, e il fulvo bocca di leone era il fiore spontaneo più nobile attorno a cui ronzavano le vespe e i calabroni con il tono flebile e ondeggiante di un lontano brusio di cirri di mare inanellati dalle brezze giocose, e le rondini pellegrine vi tornavano nel cielo terso di ogni primavera per riprendersi i nidi rimasti ad attenderle intatti, e le famiglie dei passerotti crescevano gaie nella quiete tiepida dell’abbandono, e la volta della piazza antistante era un broccato inesausto di volteggi e di voli, di garriti e cinguettii festosi.
Tutto animava il libero divenire della natura e del tempo, solo Filomena era incatenata a un vecchio rinsecchito e nascosto. Egli, nulla conservava della giovinezza o dell’età matura: ne fattezze, né lineamenti, né accenti sia pure appesantiti, degradati nel volgere attonito degli anni della vita. Pareva caduto da un precipizio nella voragine della desolazione, e ne incarnava trasmutato tutte le sembianze. Più non vi vedeva. Di fronte ai suoi passi apparivano solo ombre malferme da scansare. I mobili, gli arredi, tutte le cose che sostanziarono il lusso trascorso avevano perso forma, contorni, colori e sfumature. Non parlava più, come se le parole avessero perso peso e significato, fossero divenute superflue a chi aveva solo tormenti da macerare e nulla da dire. Era aduso vivere nella gabbia dorata delle convenzioni, nella opacità di un vissuto senza impeti ribelli, e questa condizione gli sembrava la condanna inevitabile e definitiva.
Filomena, nelle tre stanze linde del piano più alto, appassiva i suoi anni giovanili. Si sentiva legata al vecchio signore da uno zelo che provvedeva alle necessità essenziali, non dava altri incomodi se non la penombra imposta con i tendaggi socchiusi come temesse di essere ferito dalla luce e volesse nascondersi alla vita stessa. Ella lo accudiva impietosita senza ricordarne più la ragione, senza passato e senza avvenire, fagocitata in un mondo incanutito nell’immobilità asfissiante. Passava così i suoi giorni nella monotonia che le mutilava i pensieri e i desideri, i sogni, le gaiezze e i rossori pudichi dell’età turgescente, non si accorgeva che il vecchio le stava rubando l’anima.
Un giorno, presa da un impulso misterioso, Filomena scese per la grande scalinata fino al piano terra, aprì una porta pesante e stridula, varcò la soglia con il lume acceso, rischiarò gli ampi antri con il cielo notturno incurvato. I suoi passi destarono gli echi dei soffi delle cavalcature e l’odore acuto di strame nella scuderia deserta. Più in là, si addentrò nei freschi magazzini: passò dove si accatastavano, forma su forma, le pile del cacio, e in alto si appendevano le rocche dei salumi e i graticci di canna reggevano il granturco rinsecchito, steso leggero; per terra si ammucchiavano i poggi di grano dai vaghi riflessi dorati, e l’olio limpido giaceva immoto nelle giare di creta, e le grandi botti zaffate risuonavano sorde dei bollori acquetati del vino. In questo luogo affluirono le fatiche secolari dai meandri della terra, le maledizioni e i desideri umiliati dei popolani, ma Filomena era presa da altri pensieri e continuò a cercare senza sapere cosa. Scorse seminascosto un piccolo passaggio segreto, giunse fino in fondo e aprì una porticina: si vide riflessa nel lucore d’uno specchio ampio e nel bagliore candido della lenzuola di lino ordinati sul letto. Le pareti erano cieche, senza aperture, e su quella a cui era accosta la testa del letto qualcuno aveva raffigurato una Venere languida nell’atto di donarsi a un dio ardimentoso e guerriero su uno sfondo di mare turchino, tanto intenso da dare il senso a cui si ispirava quel rifugio di ombre trepidanti nella gallica mitologia da ultima tule del regno.
Filomena sentiva alitare attorno a sé una presenza invisibile, incomprensibile, ma che non la inquietava. Sul piano di marmo rosato del comò era posata una guantiera d’argento con la bottiglia del rosolio, una caraffa d’acqua e quatto bicchieri, piccoli e grandi. Invaghita in un sogno stupito, tirò verso sé il tiretto più alto del mobile e fu investita da una folata inebriante di profumo di violette, vapori lungamente compressi che i suoi sensi, scossi dal torpore profondo, non avevano mai odorato. Un fremito caldo e vitale le trasalì nelle vene, svelava a sé stessa, per la prima volta, la prorompente essenza femminile ignorata, e ne fu turbata. Prese l’ampolla del profumo e scappò via impaurita e confusa. Ormai il suo essere e il suo sentire si sarebbero rivelati intrisi per sempre nel profumo delicato delle violette.
Nella penombra delle tende di seta socchiuse, il vecchio era seduto sulla poltrona col capo chino, come genuflesso smarrito nel vuoto della sua perenne assenza, e, all’improvviso, ebbe un sobbalzo. Un soffio leggero gli entrava nelle frogie cavernose, e come un alito di vita innervava il corpo macilento, dava espressione e colore umani al volto impresso dall’ansia. Volgeva lo sguardo nella direzione da cui Filomena si avvicinava e quando l’ebbe accanto esclamò sospirando:
“Assunta, sei tornata! Pensavo di averti perduta per sempre, ma tu sei tornata. Hai messo il profumo dei nostri momenti felici per dirmi che mi hai perdonato.”
Ella ascoltava e lo guardava con le sue pupille tralucenti fiori di lino inumiditi di rugiada. Aveva il petto in tumulto. Per una misteriosa fatalità la madre defunta si chiamava Assunta e le era ignoto il padre. Le tornavano in mente tutte le domande rivolte alla madre, i silenzi, le risposte elusive, i desideri inappagati. Perciò, Filomena non chiese nulla, avrebbe rotto l’incantesimo che pervadeva il vecchio, avrebbe ricacciato il grumo doloroso che si scioglieva su quelle labbra sitibonde come una confessione liberatoria, la rivelazione lungamente attesa. S’inginocchiò davanti alla mano scarna, la prese e vi pose la soffice gota impallidita, e il vecchio ricominciò a parlare:
“Assunta, ti ho fatto il male più vile, quando ti scacciarono da questa casa non alzai un dito, non fui uomo, e il rimorso mi rinchiuse nel buio della vergogna per pagare la colpa della mia inettitudine.”
Queste parole rivelavano il bigottismo delle vite parallele dei ricchi signori: i codici del sangue, delle apparenze civili e religiose, le pubbliche virtù e gli amori nascosti con la servitù e le popolane avvilite e sottomesse che generavano i figli di N.N., dimenticati nel disprezzo comune e la vergogna, come dovessero scontare le colpe sacrileghe dei padri ignoti, il destino ineluttabile di Filomena. Ma ella, forse, comprese il senso dell’espiazione del padre rivelato per giungere al riscatto, alla riconciliazione suggellata dall’alone profumato dalle violette. Forse, fu proprio Assunta a voler porre fine alla sofferenza, cogliendo dal polso dell’amato l’ultimo palpito di vita, cambiandone il destino segnato dalla disperazione, e liberare Filomena dall’incubo in cui era caduta.
Anche il palazzo è stato liberato dai suoi pesi, e tende le creste dei ruderi al cielo ad invocare invano gli amori e i fasti trascorsi. I raggi del sole, penetrando dai tetti crollati, lo consoleranno, le piogge lo batteranno, ed esso resisterà, dimora della memoria, delle piante di vento, delle rondini e dei passerotti, finché ne avrà la forza.