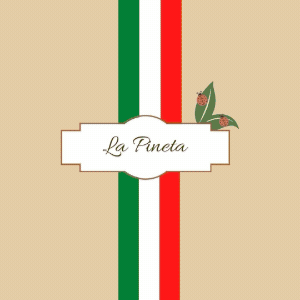di Francesco Tuccio
Da una finestra al primo piano del cascinale sulla strada Cartman, scrutava le colline torinesi per cogliere un cenno che somigliasse alla sua terra lontana. Guardava con gli occhi sognanti di chi, laggiù, aveva lasciato qualcosa di suo e le tornava nella mente con il ronzio tedioso della sofferenza.
{loadposition articolointerno, rounded}
Alitava in lei un fuoco appiccato acerbo che, al soffio di altri venti, temeva potesse spegnersi. Mariarosa, ragazza quattordicenne, sul davanzale poggiava i gomiti e le braccia, affondava il collo nelle spalle ristrette, mostrava i lievi gonfiori del petto palpitante ai fremiti delle mutazioni dell’essere, e intrecciava le dita affusolate, avvolte dal tessuto sottile dei pori iridati di taluni germogli primaverili, impresse lievi alle punte dalle prime incombenze della vita. Era un timido bocciolo di petali rosa appena schiuso, e traluceva del bagliore di quei volti alati che si vedevano sospesi tra i fregi e il fulgore delle cose divine nelle chiese antiche del Sud profondo. Stava lì, appesa sulla terra come giunta dalle profondità cristalline, umida ancora della fresca rugiada perlata che le irrorava gli occhi e la bocca tumida, e le sue labbra parevano parlare delle origini mistiche e arcane della bellezza ignara. Portava con sé i lineamenti delicati delle essenze della natura nuova di maggio, quando nella sua terra l’aria traspariva un tepore fluido, e un profumo alto e sensibile vibrava dei canti e dello sciaguattare delle lavandaie di fiumara, delle voci e dei rumori di campagna balzati da poggio in poggio, ripresi e ampliati dai raggi del sole come echi rotolati da versante in versante. Le fiumare, allora, si facevano meandri erranti di pioppi, oleandri e canneti, e i prati variopinti, dai laghi gemmati dalle margherite, dalla sulla porporina e dal quadrifoglio scampanellante, dipartivano da fondovalle con la candida zagara, risalivano le pendici con le turbe degli olivi in fiore, indugiavano sulle aie all’ombra dei fichi e dei gelsi, giungevano all’incontro culminante sulle balze delle dorsali con il giallo acceso della ginestra. L’alto stelo dell’agave carnosa vi fioriva sui poggi cretosi e le creste dei burroni, laddove le greggi arrampicavano per brucare l’erba scarnita. Il cielo cerulo suonava come un cristallo, si univa al concerto delle note umane e delle cromie naturali; scandiva, sovrano, i volteggi della melodia in cui si scioglievano le sofferenze e le fatiche delle valli, e prolungava nelle chiese il chiarore crepuscolare.
E nelle chiese i ragazzi, con le zazzere impomatate, e le ragazze, con le corolle di trecce attaccate alla nuca, si adunavano come stormi d’uccelli posati sugli alberi notturni e umidi, penzolanti dei frutti più maturi e saporosi. Intrecciavano canti alla Madonna Immacolata, splendente nel volto levato al cielo e la testa coronata di stelle, ammantata d’azzurro broccato d’oro; e, come fossero nati con gli occhi aperti nei recessi reconditi dell’età giovanile, intrecciavano sguardi furtivi e segreti a cui affidavano pensieri cupidi e turbamenti, lieviti ignoti e sognanti nell’aura trascendentale di un pullulare quieto e vivo di colori velati, del lume delle candele sugli altari policromi, degli effluvi dei fiori e degli incensi, dei suoni delle canne dell’organo nella navata incurvata e istoriata dalle apparizioni celesti, fregiata dagli stucchi dorati, sorretta dai cornicioni e dalle colonne barocche. Tutto fuggiva a Dio attraverso le alte vetrate cobaltine, e destava le nicchie dei santi e le pietre tombali. Il mese mariano era il mese degli amori: rinverdiva i vecchi e ne faceva nascere nuovi, accaldava le gote, pulsava le palpebre e il cuore, congiungeva i destini nella vacua promessa del regno delle cose piccole e belle, della felicità di una vita agreste ed essenziale. Mariarosa non sapeva, e non avrebbe voluto divincolarsi dallo sguardo di Cosimo, un contadinotto bruno diciassettenne. Lusingata, abbassava gli occhi per pudicizia, ma sentiva lo sguardo di lui come un tenero abbraccio che la faceva trepidare. Nelle loro menti, evanescenti e sognanti, si erano già promessi, e una sera Mariarosa ebbe il coraggio di porre i suoi occhi in quelli di lui, di indugiare come volesse parlargli di tutta la tristezza che aveva dentro: quel microcosmo d’incanto per lei era alla fine e sentiva pesante il presagio di un orizzonte offuscato. Cosimo increspò gli angoli della bocca in un sorriso nascosto e compiaciuto, quasi spavaldo, poi si ritrasse pensieroso e corrugato, ma non comprese.
Dalla sera successiva, Mariarosa non tornò più in chiesa, e lui divenne un passerotto sperduto: emetteva versi striduli soffocati vedendosi aprire il precipizio sotto di sé. Già batteva prepotente l’onda del distacco e della lontananza; nel suo petto spume bianche si levarono e s‘infransero, e una spessa coltre d’acqua l’avviluppò nel vortice dello sgomento.
Non si diede per vinto. Cosimo chiese e attese. Aveva finito la mietitura e la trebbiatura del grano, e dopo aver raccolto un gruzzoletto con il suo lavoro a giornata, ebbe un indirizzo:
“Strada Cartman, 148 Torino”.
Quella striscia di carta la girò e rigirò tra le dita, la impresse nella mente come fosse la sua stella polare e volesse stabilire la distanza e la maniera per arrivare nella grande città, che immaginava vagamente dalle cose udite in paese, e la sentiva ostile e pericolosa come fosse il mondo degli uomini cattivi, lontani dal suo modo di vedere le cose.
Decise, d’un tratto, in una delle notti insonni. Saltò dal letto e preparò la partenza: indossò un pantalone di velluto scuro, una camicia scozzese, le scarpe nere. Alla rinfusa mise nella valigia di cartone pestato la biancheria di ricambio. Prese la giacca buona di velluto marrone e frugò furtivo nei cassetti del padre. Scappò via come un ladro notturno, lasciandosi dietro un eco di passi di feltro nel silenzio origliante delle case mute e spente. Uscì dalla rupe del paese e prese per il pendio che conduceva, attraverso gli orli dei campi di stoppie e il salto dei grilli zittiti, al nastro ondivago dei ciottoli della fiumara, argentata da uno spicchio di luna crescente che gli mostrava confuso il cammino. Da lì, l’accompagnarono fino alla marina le ombre dei ciuffi degli oleandri e dei filari dei canneti, e gli stagni sorpresi e ristretti dal sole scrosciante di giugno. Le foglie dei pioppi stormivano in alto con voce suadente per acquetare le ansie del passo e dei pensieri, e le fratte degli orti si aprivano generose per mostrargli i frutti dissetanti e teneri come lattughe. Il canto gracidante delle rane lo precedeva e si ammutoliva al suo passaggio finché non prese la strada ferrata, fiancheggiata dai gerani in cespugli fioriti e cadenti. Salì sul treno per il Nord nella piccola stazione ferroviaria, posta in faccia al mare e alle barche che sul chiarore vermiglio dell’orizzonte si stagliavano con pennellate fugaci di nero, come pietre opache appiattite su cui rotava il volo dei gabbiani attratti dai pesci impigliati nelle reti, luccicanti al sole nascente come riflessi di specchi affioranti dalle profondità screziate d’azzurro incupito. La locomotiva fischiò e si mise a soffiare affaticata un respiro di fuoco nell’aria, risentiva del gravame delle carrozze che si lasciavano trascinare controvoglia. Per tutto il viaggio, Cosimo tenne stretti la valigia e i soldi che aveva nella tasca interna della giacca, le persone che salivano e scendevano ad ogni fermata gli parevano pronte a derubare le sue miserie e le guardava con occhio malinconico e torvo.
In un pomeriggio di sole sbiadito, dalla finestra, Mariarosa vide un ragazzo sperduto con la valigia ciondolante sul ciglio della strada Cartman, una vena di periferia della Torino del tempo, da dove i locali avevano abbandonato gli edifici rustici e le terre per abitare in città e lavorare nelle industrie crescenti. Chiedeva qualcosa ai passanti e qualcuno con il braccio alzato e l’indice teso gli mostrò la direzione del cascinale dove lei abitava assieme ad altre famiglie emigrate dal Sud. Quando fu più vicino, Mariarosa, sorpresa e ridente, lo riconobbe. Era Cosimo venuto dal paese apposta per lei, non ebbe dubbi: non l’aveva dimenticata, la cercava per unire i suoi passi in un nuovo cammino, e lei con il petto in tumulto si sbracciò dal quadrato della finestra gridando:
“Cosimo! Cosimo!”
Il ragazzo si voltò verso quella voce squillante e si mise a correre, felice per averla finalmente raggiunta. Si fermò sotto la finestra. Il mondo apparso nemico crudele tornava nelle addolcite fantasie di quello sognato. Il loro sentimento era nato in chiesa senza parole, e ora le cercavano con l’affanno della prima volta. Le trovarono guardandosi e guardandosi dentro, nella semplicità del loro essere giovanile.
“Ti ho trovata! Finalmente, ti ho trovata. Non riuscivo a stare senza di te e sono partito. Ho intenzioni serie io. Se mi vuoi, sono venuto a chiederti in sposa a tuo padre”.
Le disse Cosimo, e lei rispose:
“Si che ti voglio, ma devi aspettare. Non ti posso aprire! Non c’è mio padre. Aspetta, fra poco torna dalla fatica.”
Cosimo fu contento per quelle parole. In una casa onorata nessuno poteva entrare se non c’era l’uomo a cui apparteneva. Ma guardandola ancora, un’ombra attraversò i suoi occhi. Mariarosa era castana ed ora la ritrovava bionda. Aveva le trecce tagliate, la punta dei capelli le lambiva gli omeri; fluenti fili d’oro intonavano sul colorito roseo delle gote le luci e i brusii della seta d’opale. Da una bellezza ne era nata una nuova che a lui parlava una lingua straniera, incomprensibile; quella d’una creatura che voleva appartenere alla città avviata al futuro, lontana dalle case vuotate e solitarie, dagli stenti vissuti. Mariarosa l’aveva vista: le strade larghe come le fiumare che dalle montagne correvano al mare, i palazzi lunghi e più alti dei campanili delle sue chiese attorno a cui s’aggomitolavano le case basse con i muri scorticati dal tempo, le vetrine dei negozi sfavillanti delle promesse allettanti di un altro mondo, apparso con lo stupore d’uno stordimento improvviso e fatale. Aveva compreso i segni e i tempi di una nuova vita che non le impediva di conservare vivi le memorie e gli ardori del paese. Cosimo dentro di sé tagliò corto per rassicurarsi:
“Ora che ci sono io, metterò le cose a posto”.
Dal cielo già fioccavano ombre ingrigite, e la guazza bagnava il prato antistante il cascinale, e gli alberi intorno tendevano le foglie nel fresco serale. Il padre di Mariarosa tornò in quell’ora. Guardò Cosimo seduto su una panchina. Lo guardò in tralice, e il ragazzo, rimpicciolito, scattò in piedi per salutarlo. Entrarono in casa e sedettero intorno al tavolo di una cucina spoglia, ridotta alle cose povere e necessarie. La madre di Mariarosa arrivò, non si sa da dove, e silenziosa posò sul tavolo la bottiglia del vino e due bicchieri, poi scomparve imboccando una scala per raggiungere i figli in attesa impaziente al piano di sopra. Quel che dovevano fare era un discorso da uomini.
Cosimo, da quando partì non fece altro che mulinare le cose da dire nel momento sentito alla svolta della sua vita, ma, ora, si mostrava impacciato, intimorito, non sapeva come cominciare, quali erano le parole più giuste per convincere l’uomo che, arcigno, gli stava di fronte. Alla fine scelse la via più semplice e schietta del contadino che era:
“Io e Mariarosa ci vogliamo bene e vi domando il permesso di sposarci.”
Lo disse tutto d’un fiato, come avesse fretta di liberarsi da un peso sulla bocca dello stomaco, e la risposta non fu quella sperata.
“Sei ancora “cotrado” (ragazzo) e Mariarosa è una bambina. Non avete l’età per queste cose che sono cose da grandi, e tu non hai neanche un lavoro.”
Cosimo, incupito, cercò di risalire dal fondo in cui era stato ricacciato dicendo:
“Il lavoro me lo stanno cercando degli amici ad Alba. Sono robusto io e la fatica non mi spaventa. Stavo comodo al paese, ma se sono qui è perché voglio bene a vostra figlia ed ho intenzioni serie.”
“Il lavoro te lo posso trovare pure io, la mia ditta a Fenis sta costruendo una strada e posso chiedere se c’è un posto pure per te. Là si usa pala e “pico” (piccone) e lo puoi fare anche tu che non hai un mestiere. Ma di mia figlia e di matrimonio non se ne parla. Non so neanche cosa pensa tuo padre. Stasera puoi mangiare con noi, io non caccio nessuno, e per dormire ti trovo un posto da amici. La mia è una famiglia onorata e sotto lo stesso tetto di mia figlia tu non puoi dormire. Non voglio dicerie sul conto di mia figlia e che di me si dica in giro che ti ho accalappiato”.
Queste furono le parole della gelosia protettiva che conosceva gli uomini e la mentalità di un luogo lontano. Parole definitive, dure come una condanna senza appello. Il padre di Mariarosa chiamò la moglie per preparare la cena: maccheroni al pomodoro.
Quando la pasta fu sul tavolo, chiamarono Mariarosa. Scese con i due fratelli più piccoli. Sedettero come attorno ad una pietra tombale, tanto fu profondo il silenzio, sordo e opprimente, rotto di sfuggita dal fischio del sugo nei maccheroni inforcati e risucchiati a bocconi. Il padre spiava Mariarosa e Cosimo che, con il capo chino e gli occhi fissi sul piatto, si ignorarono. Forse, scambiavano i pensieri e i propositi degli amori proibiti, la ribellione che covava nella cinigia, pronta ad avvampare inaspettata quando lambiva i legni più teneri e dolci.
La notte stese un velo insonne, crespo di sospiri affannati, lacero ad ogni moto dei corpi inquieti, adagiati sul letto. Dov’erano finiti le occhiate, le parole taciute, i tremori e le voci dei canti? Dove gli entusiasmi e i sogni? Tutto svanito nel mondo ostile dei grandi, al di là delle soglie del tempo eterno e la solennità delle chiese. E la luna le guardava dall’alto quelle vite impigliate negli inganni e le disillusioni del conflitto iniziato tra padri e figli. Un vento fresco tirò l’aurora con lo sfondo rosso metallico del Nord, strisce color cinereo passarono il Po e ricaddero sulle famose colline incurvate come mammelle nella letteratura pavesiana. Cosimo, attorcigliato sotto le lenzuola, origliava attento i rumori intorpiditi di quel formicaio che era divenuto il cascinale. Là, batteva l’ora del lavoro nei cantieri e nelle ciminiere mai spente. Al suo paese le stalle erano già chiuse, i contadini a cavalcioni sui basti degli asini e dei muli erano oltre le porte, per i sentieri scoscesi delle fatiche secolari di campagna. Ma Cosimo pensava ad altro, doveva attendere che il mattino fosse avanzato.
Ad uno ad uno sbucarono tutti, ad ondate: prima gli uomini frettolosi e poi le donne con il passo placido delle colombe, e per ultima la madre di Mariarosa. La fermata dei tram di Sassi, poco distante, si era popolata di facce meridionali, poi vuotata e popolata di nuovo; incessante mobilità delle frenesie di questi luoghi a cui rispondeva la quiete di paese, La ragazza, ora, era sola con i fratellini. Questo era il momento atteso da Cosimo, che lesto si presentò sotto la finestra del cascinale. Lei apparse dietro i vetri con una camicetta a righe rosa e verde, il volto incastonato nei capelli biondi. Aprì le imposte; un riflesso mesto girò per la stanza scialba e disadorna, e lei si affacciò raggiante e con gli occhi tristi, segnati dalle lacrime e dai pensieri della notte.
“Scendi, dobbiamo parlare.”
Le disse Cosimo, facendo con la mano uno sventolio insistente.
“Non posso, mio padre mi ha detto che non ti devo vedere. Non posso disubbidire.”
Replicò angosciata Mariarosa.
“Se mi vuoi bene veramente, devi scendere. Ti ho detto che dobbiamo parlare di cose importanti che ci riguardano.”
Il tono della voce di Cosimo andava mutando e lei sentiva che stava per tradire il suo sentimento e la sua promessa. Chiuse la finestra e scese, combattuta tra l’obbedienza che doveva al padre e la richiesta della persona a cui voleva bene e temeva di perdere. Si incontrarono e sedettero sulla panchina. L’erba era ancora bagnata, e in fili sottili ripiegati su se stessi inumidì le loro mani che si strinsero accaldate. Nel cielo il sole giocava a nascondino dietro nuvole di pioggia, affastellate e pellegrine.
“Scappiamo! Andiamo via, tuo padre non ci lascerà sposare né mo’, né mai. Se non vieni via con me non ti vorrò più vedere. Vieni, i soldi per tornare in paese ce l’ho io.”
E tirò dalla tasca un mazzetto di biglietti da mille lire arrotolati, in parte guadagnati e i più derubati al padre nella notte della fuga precipitosa. Lei rimase pensierosa, col dorso della mano asciugò i lucciconi scappati sulle guance arrossate e rispose con un sospiro che sapeva di cedimento rassegnato ad un ricatto tagliente:
“E vabbe! Ma però al paese non ci torniamo. Chissà cosa diranno di me, come mi guarderanno, e poi non voglio tornare a fare la vita che ho lasciato. Dove vuoi, al paese no!”
“Hai ragione. Lì potrebbe tornare tuo padre a riprenderti. E poi chi ci farebbe le carte per sposarci senza il si dei genitori. Siamo minorenni.”
Inavvertitamente, Cosimo parlò come chi la sapesse lunga. Il suo proposito avventuroso rimetteva i piedi a terra, e Mariarosa lo comprese, e si aggrappò subito a quell’appiglio dicendo:
“Allora, vedi che è inutile scappare se nessuno ci potrà sposare. Rimaniamo …”
Non le lasciò finire quel che voleva dire. Si alzò adirato e sprezzante:
“Allora addio per sempre! Non verrò più a cercarti. Stattene con tuo padre e tutti i tuoi che stai meglio.”
Fece per andarsene offeso e dopo due o tre passi lei gli gridò angosciata:
“No! Aspetta! Fammi salutare Pietrino e Micuzzo.”
Corse in casa, entrò in cucina, salì le scale, abbracciò i fratelli sorpresi, inconsapevoli, prese un impermeabile rosso e ridiscese piangendo.
Mariarosa, al fianco di Cosimo, percorse a ritroso un pezzo del viottolo che conduceva alla strada della fermata dei tram; guardava gli occhi smarriti dei fratellini dietro i vetri della finestra chiusa. Cominciò a piovere e su quei vetri appannati si stese un sipario ingrigito, sempre più lontano e indistinto. Mariarosa, stretta nella dolorosa incertezza incomprensibile a sé stessa, lasciava il cascinale per entrare nella vita anzitempo. Ed era sola.
Milano li accolse con la sua faccia serale. Scesero dal treno nella grande Stazione Centrale, s’immersero nella marea delle persone che carichi di bagagli muovevano confuse in ogni direzione, come buttate lì per caso in un luogo sconosciuto, senza sapere dove andare. Il vociare e i rumori e gli echi lontani accrebbero soltanto lo smarrimento che avevano dentro. Ne uscirono con passo svelto e furono subito in strada a cercare un posto dove passare la notte. E la strada si allungò con le luci effuse di un cielo vispo di stelle, percorsa da un sangue frenetico, colorato dalle vetrine e dai lampioni. Le persone che camminavano sui marciapiedi non si conoscevano, oppure facevano finta di non conoscersi. Cosimo non lo sapeva. Notava che tra loro non c’era il saluto obbligato e rispettoso del paese, le conversazioni, le sorprese dei giorni sempre uguali, le adulazioni di maniera, i retro pensieri e le morsicate cattive. Gli sguardi s’incrociavano per un attimo, si raggrumavano attorno ai negozi e alle fermate dei tram, poi fuggivano di nuovo per cercare altri sguardi e non si fermavano in un divenire inesausto, come quello dei veicoli che transitavano sull’asfalto col barbaglio dei fanali bassi. Cosimo stese il braccio sulle spalle di Mariarosa e le disse:
“Il bello della città è che non ti conosce nessuno e puoi fare i fatti tuoi. Ma bisogna stare attenti perché qui le donne non sono rispettate, non è come al paese. E le donne non devono provocare con i capelli, gli occhi e le labbra pittati, i vestiti attillati.”
Mariarosa, stretta nel suo impermeabile rosso, non rispondeva, mentre il giudizio del padre, che le aveva permesso di tingersi i capelli, si dilatava e assumeva il formicolio di un vago rimorso.
Un cartello su un portone, “FITTASI POSTI LETTO”, stroncò quel dialogo sordo e sordido, e Cosimo, seguendone l’indicazione, la trascinò nell’androne del palazzo. Salirono le scale fino al terzo piano, lasciandosi alle spalle i rumori e le luci della strada. Lei, ormai, lo seguiva come un agnello riluttante condotto al macello. Ed ebbe ragione. Furono introdotti in uno stanzone suddiviso ad alveare. Solo i muri di masonite delimitavano le celle strette e spoglie. Ma il locatore con loro fu magnanimo e gli assegnò un buco con una finestra nascosta da tende unte e sudice, come le coperte e le lenzuola poggiate sui due lettini. A Mariarosa le strinse il cuore, e quando furono lasciati soli raggelò il ragazzo che le stava davanti fremente.
“Non qui! Andiamo via! Domani sarà troppo tardi. Non posso tornare da mio padre dopo avere passata la notte qui con te. Andiamo via!
Parlò decisa, quasi bisbigliando per non farsi ascoltare dagli estranei che condannati nelle loro celle emettevano qualche rumore, qualche colpo di tosse, qualche sbadiglio assonnato. E il ragazzo con cui era fuggita si rivelò parimente un estraneo, chiuso nel suo desiderio rude che non conosceva l’ascolto, la comprensione e la tenerezza. La fece sedere sul letto e cominciò a sbottonarle l’impermeabile rosso. Lei cercò di divincolarsi e lui le strinse i polsi, la sentì debole e rigida alla stesso tempo, e, per vincere ogni altra resistenza, le disse:
“Ormai tutti sanno che sei scappata con me. Sei mia, e se non ti tengo io non ti vorrà più nessuno.”
A Mariarosa non rimase che il pianto e quel grido strozzato che la vergogna le ricacciava nella gola inaridita. Lui la prese per la nuca e la stese sul lettino, pose annebbiato le labbra sulle sue, e fu come affondarle in una fonte diaccia. Lui scendeva come una biscia sulla fossetta del collo e lei passò la mano sulla bocca per cancellare quel bacio tante volte sognato nel suo campo di papaveri rossi, quando il vento li accarezzava in un ondeggio infinito e i petali s’involavano al soffio degli afflati dell’anima.
Ora, l’uomo è qua, rannicchiato sul letto, confitto immoto in un sonno senza vita. E’ pesante il suo fiato; ha la protervia di quello animale che non ha ricordi delle ferite inferte, della dignità lacerata, dei sentimenti infranti.
Mariarosa è seduta, denudata, staccata dalla vita. Sente pulsare nelle vene il sudiciume che avvolge tutta la cella, illuminata da una luce tagliente e allucinata, chiusa nel silenzio sdegnato dalle voci ammutolite. Deve staccarsi da quel lettino. Si veste, e le torna un mondo in cui più nessuno l’aspetta, dei passi che non possono riandare al cascinale, alla città, al paese. Le porte le sono tutte chiuse e non c’è un recesso per la sua gracile esistenza. Va alla finestra e la apre sulla strada deserta. La notte è fonda e lei si sporge sull’abisso delle ore vuote e finite. Per i meandri della città si perdono gli amanti nascosti, i sospiri sussurrati, la mani che si cercano nella solitudine di stanze soffuse, e lei si lascia scivolare in un viaggio buio e vorticoso. Scende leggera. Scende e si posa sulla soglia della sua chiesa. Uno schianto sveglia le canne dell’organo e i canti mariani. I suoi sensi la stanno lasciando, la bocca è ferita, ma fa appena in tempo a toccare con la mano i suoi capelli rimasti ostinatamente biondi come mimose, e poi si abbandona in un sonno sereno.