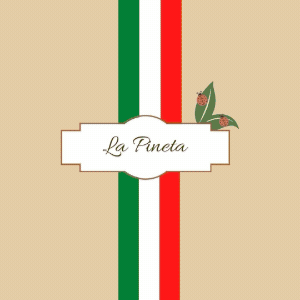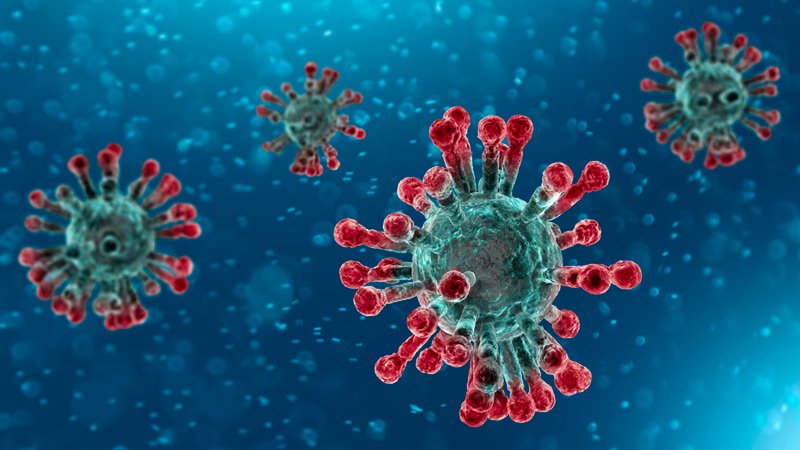di Francesco Tuccio
L’aria è liquida, palpabile, densa d’una immobilità opprimente. L’afa agostana avviluppa nelle sue matasse vischiose, stende lo scirocco in una foschia traslucida d’azzurro, stringe forte lo sguardo dalla marina alla montagna in una uguale monotonia ambrata. Il mare ingrossa torbido e verdastro, gonfia e allunga i cavalloni in una altalena incessante, si consuma, si placa nell’ultima spuma che dilaga scrosciante sulla battigia slargata; liscia, livella fine e compatta la sabbia. Tra le sue acque offre un rifugio, una culla possente, un gioco tra le onde che rimanda la memoria alla giovinezza, ad un tempo che non aveva paura del tempo. Ma bisogna andare. Occorre lanciare la sfida alla canicola e vestirsi come si conviene nella partecipazione mesta ad un evento luttuoso.
{loadposition articolointerno, rounded}
Il paesino è in montagna, sperso, nascosto in una delle pieghe della grande vallata dell’Allaro, proprio laddove le sue acque dissolvono inghiottite dalle gole aspre e profonde, cesellate nella roccia primigenia. La strada, prima inerpica lungo i costoni, e poi fende i fianchi ripidi della montagna. E’ come un’aperta, lunga e contorta ferita inferta violenta nella carne viva dei boschi, un tributo per rompere la bruma dell’isolamento avito, l’arretratezza e far giungere il progresso. L’esile striscia d’asfalto ne sutura incerta i lembi laceri, indugia negli stretti tornanti, attraversa falesie e dirupi, denuda le vene della roccia squarciata dove cresce il muschio e si radicano gli arbusti d’erica come croste riparatrici, gode dell’ombra fitta dei lecci e dei castagni secolari punteggiati copiosi di ricci gialli e spinosi. Dalle alture la visione spazia incantata, ondeggia nel verde cangiante, mosso da versante in versante da cui spiccano le brevi radure dei coltivi, il rumore brucante delle capre abbarbicate sui burroni, il grufolare dei cinghiali nel fitto fogliame, il fiato della melogna acquattata nella tana, il volo del falco roteante, e tutto si perde nel profilo indistinto delle cime più erte.
Una fontana d’acqua gelata si offre generosa alla sete dei passanti, ma il ristoro è rotto dalle lapidi lungo la strada: scuotono e riportano alla tragica storia recente del luogo. Richiamano pietose un segno di croce, una preghiera, un ricordo; urlano con voce stentorea un monito contro le faide delle ‘ndrine, la follia del dominio dell’uomo sull’uomo per porre mano alle risorse dei boschi, dei lavori o chissà a quali altri traffici. Al primo assassinio seguì una spirale di odio e di vendetta che parve infinita. La miseria lungamente compressa ha trovato nuove esplosioni nell’abbrutimento, nelle scorciatoie del malaffare, del terrore, e soltanto la fuga precipitosa diede scampo alla cecità degli agguati sanguinari.
Ma l’ingegno, l’operosità, il cuore pulsante degli abitanti del paesino sono nella pietra scalfita e messa in posa nei muri a secco che sorreggono esili terrazzi e cingono in un caldo abbraccio i fianchi acclivi della montagna. Lo si vede chiaramente alla fine della strada che introduce nell’abitato. Basta guardare verso l’alto per scorgere il susseguo delle strisce degli orti umidi e ombrosi, con i sarmenti ricchi di verdi pampini e di grappoli acerbi, con il filare dei pali e delle canne annodate accuratamente, e le piccole opere idrauliche dove l’acqua saltella a rivoli per inseminare la terra di teneri, forti germogli. E’ come la grande scalinata di un tempio primordiale aperto al sole, eretto alla fecondità della terra e far giungere in cielo il sudore della fronte a propiziare un raccolto di frutti bastevoli nel volgere delle stagioni e della vita intera.
Il piccolo abitato, aggrappato alla falda che si eleva tra gli echi dell’alveo della fiumara, non ha nulla di strano e di inconsueto. Ripete, come ogni nostro paese, un microcosmo di pietra e di verde violato, violentato dal cemento, dagli intonaci, dai tetti di eternit o coibentati, dagli infissi in ferro, da qualche fronzolo che accentua il ridicolo, risalta la beffa di una modernità acritica, malintesa. Stupisce la foggia uguale delle case, senza qualcuna più grande e imponente a testimonianza che qua i ricchi signori non hanno mai messo piede. Pare non abbiano osato comandare sulle selve, sulle radure, sui terrapieni, sulle bestie e sugli uomini che hanno potuto vivere nella libertà degli affanni.
La cultura d’una antica saggezza si è fatta memoria: alita per i vicoli stretti con gli imbriferi accanto per la raccolta delle acque piovane, quando la montagna riversa fremiti di paura e la voce dell’Allaro si fa assordante; attraversa il grumo delle case di pietra dagli antri bassi e le tegole rosse fissate nel tempo, quelle dell’abbandono, vuotate dalla diaspora dell’emigrazione, dove i focolari stampati nella fuliggine rimangono spenti e le ragnatele trattengono come raggelati le parole e gli aspri respiri trascorsi; s’acqueta nelle polveri dei ruderi coperti dai rovi e dalle piante erratiche; si fissa eterna nell’unica chiesa con le piccole statue dei santi che hanno il volto e la passata statura dei popolani; circonda la Madonna dei Poveri protettrice, custode delle afflizioni patite, dei segreti, delle ansie, dei desideri, dei miracoli implorati e mai avverati.
La tavolozza della solitudine non ha sfumature e tutto appare un intrico di sguaiati mutamenti e ultime resistenze, di contrasti stridenti, di identità in declino. D’un tratto, squarcia la montagna, s’insinua lacerante nei meandri della valle una voce accorata, cantilenante, una nenia elevata inesausta, costringe ad un ripensamento. Proviene dal silenzio del vicolo del tempo immemore, avanza tra due file di persone dallo sguardo basso e deferente, segue il feretro del defunto e ne declama le lodi dalla gioventù alla vecchiaia.
La storia dell’uomo congiunto alle crepe viscerali della terra. La voce s’incarna in una figura minuta col nero che l’avvolge annodato alla gola. S’intravedono le mani ossute, impresse dalle fatiche, col cavo rivolto sul bastone degli anni; gli occhi stretti nel pianto; il volto affilato, coperto dalle pieghe delle passioni e dei patimenti, delle implorazioni perdute. La fronte è bassa, schiacciata dai pesi che ha dovuto sopportare nella vita. Passa in lei un riflesso di generazioni di donne con il cercine sul capo come una corona di spine. Il ricordo va alle prefiche, ma, qua, il dolore è profondo, immutabile, integro nella dignità del suo valore identitario. E solo dal pianto, dalla coscienza di sé, può prendere alito il riscatto di questa terra.