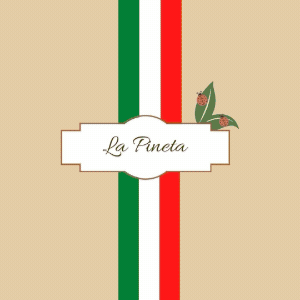di Francesco Tuccio (ph. Cecilia Piscioneri)
Sotto un sole scrosciante, tirati e molli, apparivano le scolaresche di montagna nelle fotografie ammuffite del dopoguerra.
Fanciulli.
{loadposition articolointerno, rounded}
Come pulcini nati da uova covati nei nidi di paglia, spuntavano dai casolari chiassosi e coperti di rattoppi consunti: le gambe nude, i piedi scalzi, la berretta piena di sogni e la cartella di legno a tracolla. Guardavano con le facce dai raggi sbiecate, stropicciavano gli occhi, tendevano la mano sulla fronte per frugare lontananze confuse come destini; beccavano parole sui manti erbosi delle aie e per i viottoli ghiaiosi, alzavano il capo per ingozzarle.
Parlavano con lo squillo di voci argentine:
“Signor Maestro, facci vedere il mondo!”
“E noi ti faremo sentire il canto dei cardellini.”
Il loro mondo nel folto di eriche e felci, su cime di querce e ilici, di carbonaie fumanti e speroni di roccia; nel vociare alterno delle acque, nel cinguettio degli uccelli, nello stridio delle cicale, nel frinire dei grilli, nel silenzio ruggente di un battito d’ali di farfalla. Rotolava nei burroni, con le falesie pietrose, con le frane alluvionali. Aveva i colori del latte di capra, l’ambrato del miele, il rosso delle ciliegie, il giallo delle ginestre, l’azzurro dei fiori di lino, il verde screziato della lucertola col ventre cenerino,. Stava rinchiuso nei ricci delle castagne, nei gusci delle noci, nella pelle spinosa dei fichidindia, in un acino d’uva. Profumava di cacio, di ghianda, di pascolo, di sudore di zappe per i terrapieni sorretti dai muri a secco, altari innalzati alla madre terra.
Il signor Maestro sapeva, e non voleva parlare del mondo che non vedevano gli abitatori delle spelonche, delle casupole di pietra e calce ed i tetti di tegole e frasche. Mangiavano pane giallo abbrunito nella fuliggine del focolare; dormivano su tavolacci nodosi e sacconi di foglie di granturco rinsecchite; stendevano la mano per carezzare le barbe delle capre; vedevano negli occhi degli asini riflessi di stelle; soffiavano i pleniluni negli zufoli di canna, nelle lingue dell’armonica a bocca, e dall’alto dei poggi versavano nelle valli echi di risonanze struggenti.
Il signor Maestro gli insegnò l’abbecedario, li iniziò alla conoscenza e poi volarono via; come cardellini sperduti, fagocitati cantando:
“Ce ne andiamo. – Ce ne andiamo via. (……) Noi – Vivi – Noi – morti – presi -e impiccati – cento – volte – ce ne siamo già andati – staccandoci dai rami, – dai manifesti della repubblica. – Di – notte – come lupi – come contrabbandieri – come ladri. – Senza un’idea dei giorni – delle ciminiere degli altiforni. – Siamo – in 700 mila – su appena due milioni. – Siamo – i marciapiedi – più affollati. – Siamo -i treni più lunghi. – Siamo – le braccia – le unghie d’Europa. – Il sudore Diesel. – Siamo – il disonore – la vergogna dei governi. – Il Tronco – di quercia bruciata – il monumento -al Minatore Ignoto – Siamo – l’odore – di cipolla – che rinnova – le viscere d’Europa –
Siamo – un’altra volta – la fantasia degli dei. – Milioni di macchine – escono targate Magna Grecia. – Noi siamo – le giacche appese – nelle baracche nei pollai d’Europa. – Addio, – terra. – Salutiamo, – è ora. “ (1)
“Torna signor Maestro, torna ad insegnarci un’altra vita!”
(1) Da “Il canto dei nuovi emigranti”, Franco Costabile (1965)