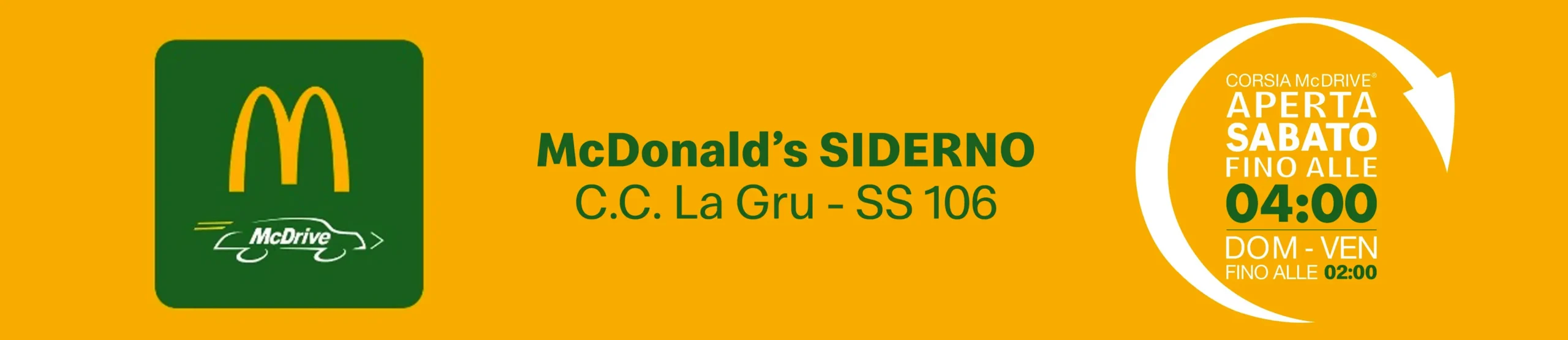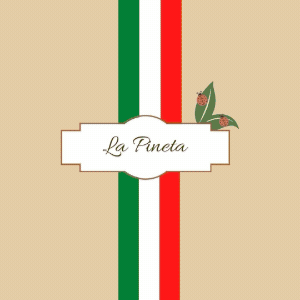di Bruno Biacchi
MARINA DI GIOIOSA IONICA – Sostanza, tanta sostanza. Poco spazio all’iconografia classica della rockstar e uno sguardo tra il profondo e il perplesso quando ascolta le domande rivoltegli. Non sai mai se stia ridendo di te e della banalità di quello che chi gli chiedi o se ti stia prendendo sul serio. Hugo Race è fatto così. O almeno, così è sembrato ai nostri occhi quando lo abbiamo incontrato ieri sera qualche ora prima del concerto che ha entusiasmato il pubblico del Blue Dahlia.
{loadposition articolointerno, rounded}
Una tazza di tè fuori orario e un abito marroncino senza cravatta. Baffetti e taglio di capelli “normale” e la pazienza di sedere sullo sgabello del tavolino di via XX settembre insieme a un giornalista e allo scrittore Vittorie Aspromonte (nella foto grande con lui), uno che di musica (e di rock in particolare) se ne intende.
A Race, che ha calcato i palcoscenici di mezzo mondo chiediamo, anzitutto, cosa si prova a esibirsi in un locale con spazi limitati, come, appunto, lo storico art cafè di Marina di Gioiosa.
«C’è una grande differenza – ha esordito Hugo Race – perché quando si suona e si canta in un locale piccolo il rapporto è più intimo e spesso ci si lascia guidare dall’empatia col pubblico, fino a cambiare persino la scaletta in corso d’opera. Proprio così: capita a me, soprattutto nelle esibizioni “unplugged”, di guardare negli occhi il pubblico e di capire che forse è meglio eseguire un brano diverso da quello previsto in scaletta. Poi va da sè che i concerti in grandi piazze servono di più a scopi meramente promozionali…»
Parliamo del tuo ultimo lavoro, realizzato insieme a due musicisti romagnoli (I “Sacri cuori”) coi quali hai dato vita alla band dei “Fatalist”; quale messaggio artistico hai voluto trasmettere?
«Ci sono le mie solite ossessioni: l’amore, la vita, le amicizie ecc. E una musica che risente sempre di più delle mie esperienze in giro per il mondo: si parte da una base di R&B e poi ci si aggiunge di tutto: musica sudamericana, tradizionale e perfino il liscio. E’ sicuramente qualcosa di nuovo».
E’ sbagliato, dunque, definirti semplicemente “rocker”?
«Diciamo che sono un cantastorie, forse tendenzialmente “noir” ma non riesco più a superare il folk delle origini dalle tante influenze musicali ricevute nella mia trentennale carriera».
Hai vissuto a Berlino ai tempi della caduta del Muro: che Europa hai trovato subito dopo, dal tuo osservatorio privilegiato di ragazzo australiano di quei tempi?
«I fatti di quegli anni m’ispirarono molto. Peccato che tutte le speranze e le aspettative di quei giorni di festa si dissolsero dopo pochi mesi con la guerra del Golfo che simboleggiò la disillusione. Rimase soltanto la voglia di esplorare un mondo nuovo, come quello dell’Europa dell’Est, così diverso dall’Australia ma anche dall’Europa occidentale. Fino ad allora era un territorio sconosciuto a noi della scena alternativa, visto che in qualche rara occasione si esibirono solo gli artisti delle principali case discografiche mondiali».
Il tè nella tazza, intanto è finito. Hugo di congeda con una stretta di mano e un dubbio: «Ma davvero inizierò a suonare alle 22.30? Al Sud Italia non siete quasi mai puntuali…».