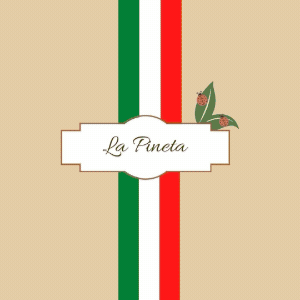di Francesco Tuccio
Ho osservato per anni quel gruppo di vecchietti di piazza della Pace. Sedevano sulle panchine nelle belle giornate di ogni stagione per raccontare e raccontarsi, e allontanare le infermità e la solitudine.
{loadposition articolointerno, rounded}
Spuntavano dagli usci delle palazzine come le lucertole per crogiolarsi al sole tiepido dell’inverno e, ansimando, cercavano l’ombra nell’estate.
Non furono in età per fare l’ultima guerra, ma della guerra avevano vissuto tutte le miserie e la fame. Uomini solari, di terra e di luna, non conoscevano il mare.
Del mare avevano sentito raccontare antiche leggende, i pericoli e le minacce dei predoni dei secoli passati e avevano perso la memoria dell’antica civiltà che ci giunse sospinta dalle ali delle vele greche.
Non furono “eterni poppanti di mandria”, ma zappatori della terra, degli aranceti delle sponde dell’Allaro e dell’Amusa, della piana d’Aguglia, dei declivi delle colline e della montagna nei filari delle vigne, negli orti segreti, gracidanti, umidi e ombrosi.
Seminavano il grano e mietevano le spighe, abbacchiavano e raccoglievano le olive, vendemmiavano nell’aria indorata e vischiosa dell’autunno. Instancabili artefici dei mulini ad acqua, dei trappeti, dei palmenti.
Seguivano gli influssi della luna che scandiva le loro fatiche dalla prima all’ultima luce del giorno, e al pari della luna seguivano le code oscillanti delle cavalcature per gli stretti sentieri accidentati dei burroni e la pariglia dei buoi all’aratro nei campi di maggese. Conservavano un ricordo vivo, ancora graffiante dell’odiata “cabeda”.
Il retaggio feudale che impinguava gli “gnuri” e rubava il frutto del loro duro lavoro. La ricordavano come le male annate di gelo e di vento, di grandine, di siccità e delle piogge alluvionali, quando le speranze si scioglievano nelle imprecazioni per la malasorte, il destino secolare che li tenne prigionieri indomiti e ribelli.
Dell’allegria ricordavano il rito cruento del maiale. Il sacrificio alla agognata prosperità, per rinnovare i vincoli parentali, comparali e amicali.
La cultura solidale contadina suggellata con la condivisione dei frutti del lavoro, col bicchiere di vino sempre pronto sulla tavola ospitale.
Mostravano orgogliosi le mani scarne, venose, ossute, segnate dai rovi, deformi, ancora callose. Nei loro corpi erano aperte e sanguinanti le ferite delle zappe, delle accette, delle roncole. I segni indelebili della storia di un popolo e della loro storia.
Erano padri solitari di famiglie numerose con i figli spersi nei continenti del mondo, accompagnati dall’incessante pianto delle madri.
D’estate il gruppo si rinfoltiva. Tornavano gli emigrati, i compagni di mille fatiche e delle baldorie dei crocchi giovanili. I racconti si arricchivano, si dilatavano ai cantieri edili e alle fabbriche del Nord, dei paesi oltre confine, oltre gli oceani. Storie lontane di un’altra vita che si rinnovavano spesso intorno al vino e il pensiero volava allegro, leggero, ai giorni di San Martino, alle cantine del paese, alle bevute ai piedi degli alberi per asciugare il sudore e sulle aie dei casolari, seduti sulle pietre di fronte alle pieghe delle valli, ai solchi delle fiumare, ai bagliori della terra.
Di anno in anno qualcuno ha dovuto abbandonare il gruppo che si è ripresentato meno numeroso e con gli occhi pieni di mestizia, con un ricordo in più da ricordare.
Stasera la luna si è affacciata su piazza della Pace e non ha ritrovato il suo ultimo vecchietto.
Stasera, è sceso il silenzio su piazza della Pace.