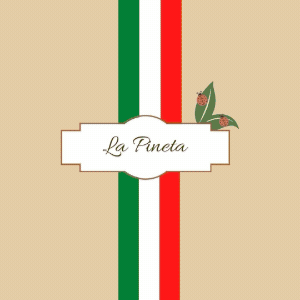di Francesco Tuccio
CAULONIA – Il mandorlo fiorito a gennaio s’è fatto messaggero di primavera, e il sopraggiungere dell’equinozio ha accordato il cielo e la terra sul pentagramma mutevole degli effluvi, delle cromie e dei suoni. Li ha distesi sotterrando i marciumi dell’inverno. Adesso, l’aria è trasparente e sensibile; e pregna di vapori tiepidi risponde come i tasti di un pianoforte pronto ad eseguire le nuove armonie di vita della natura nelle esclamazioni alte e diffuse. E’ giunta l’ora di svernare, schiudere il guscio del torpore all’apparire della Venere nell’esedra d’aranci, contornata dalle Ninfe e dalle Grazie danzanti.
{loadposition articolointerno, rounded}
“Subito, gli uccelli te, o dea, e il tuo giungere manifestano,
toccati nel cuore dalla tua forza.
Quindi fiere e armenti balzano su pascoli fecondi
e attraversano fiumi impetuosi: così, preso da incanto,
ti segue con desiderio ogni animale, là dove sempre lo spingi;
e ancora per mari e monti e fiumi che trascinano
e case frondose d’uccelli e campi ricchi di verde,
a tutti instillando nel petto amore che seduce,
fai sì che, nel desiderio, stirpe per stirpe continuino le generazioni.” (1)
Da noi, la marina e la montagna hanno il passo corto d’un cielo glauco che aduna siepi di nuvole bianche, grovigli di ginestre e cespi d’arbusti gemmati che non riescono a coprire le pendici scarne delle timpe. Le nubi stanno lassù e sospinte dalle brezze incedono lente, godono del formicolare della terra, delle pulsazioni sanguigne che spingono in faccia ad un sole versante, al guardare in alto che porta al mistero delle velature azzurrine della montagna.
Non ci vuole nulla lasciare la marina e percorrere il fondovalle dei giardini di zagara, e poi risalire i pendii e gli stretti tornanti odorosi delle essenze rideste degli ilici, delle querce e dei pini. Fermarsi su uno stretto pianoro di felci, al di là del ciglio della strada, è una impellente curiosità che Giusi interrompe sempre, ai malcapitati.
Giusi è tutto in una vecchia berretta canuta, uno zaino a tracolla e un tirso nodoso, in dieci capre ben pasciute e un cane diligente. Ormai, è dappertutto e non tollera che si guardino da lassù i versanti e i seni di collina che degradano fino allo sbarramento del mare. Il suo mondo è assai meno del raggio d’uno sguardo, d’un giro d’orizzonte accorciato. E’ composto da una casa scabra e bassa, un ventre fuligginoso con un focolaio e un forno, una soffitta di canne intrecciate, graticci su cu ballano i topi; una madia, una caldaia annerita, i grandi cucchiari intagliati nel legno duro, tutti appesi al muro scorticato; il covile è a fianco, al di là della parete del letto per sentire belati e ululati notturni, frinii di grilli all’ombra di cieli stellati; e poi, muri a secco, frammenti di terrapieni con i tralci di vite, le canne dell’orto coi rospi gracidanti, il pascolo di fili d’erba ondeggianti e un rivolo di fonte fresca e limpida; intrichi di bosco e ciocchi d’erica nei dirupi; alberi da frutta d’ogni stagione come il cacio di capra, le ricotte fresche e affumicate e il pane screziato nel siero caldo e fumante. Lieviti sapidi di neve sciolta al sole, ritorni di primavera. E tante parole per raccontarsi e dare un senso a quella vita, tanto per farsi capire.
Qui è nato, ha succhiato mammelle di capra e latte di fichi; si è inselvatichito saltellando con i ghiri sui rami di quercia, rodendo ghiande e patate, pane nero e cipolla, scalando ciliegi e castagni, sbucando agile dalle fratte, dai salti di roccia, dalle forre e dai burroni. Stava bene come una melogna ringhiosa e segreta, sapeva indovinare le orme e le piste: dei cinghiali nel fango dell’insoglio e dei lupi sulla neve. Ma suo padre lo strappò da quel lembo incarnato di montagna per portarlo in città, a Torino. E portò con sé una valigia di cartone piena, zeppa d’immagini, di gamme di colori, odori, sapori e suoni. Umori di terra diretti e crudi, miti tempranti e magici ritorni del divenire uomo.
Non fu accolto bene dalla civiltà dell’ansia e allungò il suo isolamento in una campana sorda e opaca come la nebbia. Lo intristiva il grigiore ispessito dei fumi di strade e ciminiere, il monotono sali scendi dalle impalcature, i cieli innaturali addensati d’antenne, le albe e i tramonti privi d’orizzonti, senza solitudini in cui perdersi. Un uomo di montagna è quercia con le braccia tese al sole, balla solo la tarantella al suono dell’organetto, al battito del tamburello, al ritmo di canti sguaiati, e Giusi stava alla finestra di uno schermo, artificiale come al cinema o in televisione, il mondo di celluloide distante. A Porta Palazzo cercava sprazzi di vita vera nei colori vivaci di frutta e verdura, conosciuti come il miscuglio dei dialetti di terre sventurate come la sua. E i crocchi dei paesani attorno al vino, che non aveva nulla della forza e degli umori stillati da certi soli, versavano meste nostalgie. Aveva guadagnato e messo su famiglia, ma la notte gli era tormento, pungente come i fichidindia, i ricci delle castagne, le siepi di rovo. Le immote memorie delle sue lontananze remote l’assalivano: echi e sussurri trapassavano il corpo inquieto, steso sul letto. L’alba riaccendeva la promessa: quella vita interminabile sarebbe stata provvisoria, il volgere di lunghe stagioni da buttare dai suoi precipizi. Lo soccorse lo scivolare lento verso l’età crepuscolare in tempi di miseria. Quel che aveva non gli fu più bastante e nel rovistare tra i rifiuti non trovò la fine della vita, ma la dignità della fatica, la sua sorte segnata. Ed affrettò i suoi passi.
Ora, è tornato! E’ tornato con i lupi. Ha rivisto gli alberi e la topaia che l’attendevano, il cinghiale mangiare l’uva e dissodare l’orto, i ghiri gonfiare con le ghiande, le capre con il muso teso in aria ad annusare il lupo, le melogne ascoste nelle tane, e le vipere abbeverarsi tra i sassi dei torrenti. “Sto attento!” Dice. “Ma qua è tutto bello, è la mia indole selvaggia. Qua voglio morire per tornare a vivere sperso tra le essenze della mia natura.” E dicendo arride alla rivincita, dissolve nell’ombra lunga della sera: è solenne come un pastore arcaico e stanziale.
(1) Da Lucrezio, De rerum natura – La natura delle cose – (Tito Lucrezio Caro, 50 a.C.) a cura di Guido Milanesi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1992