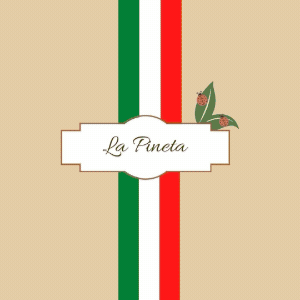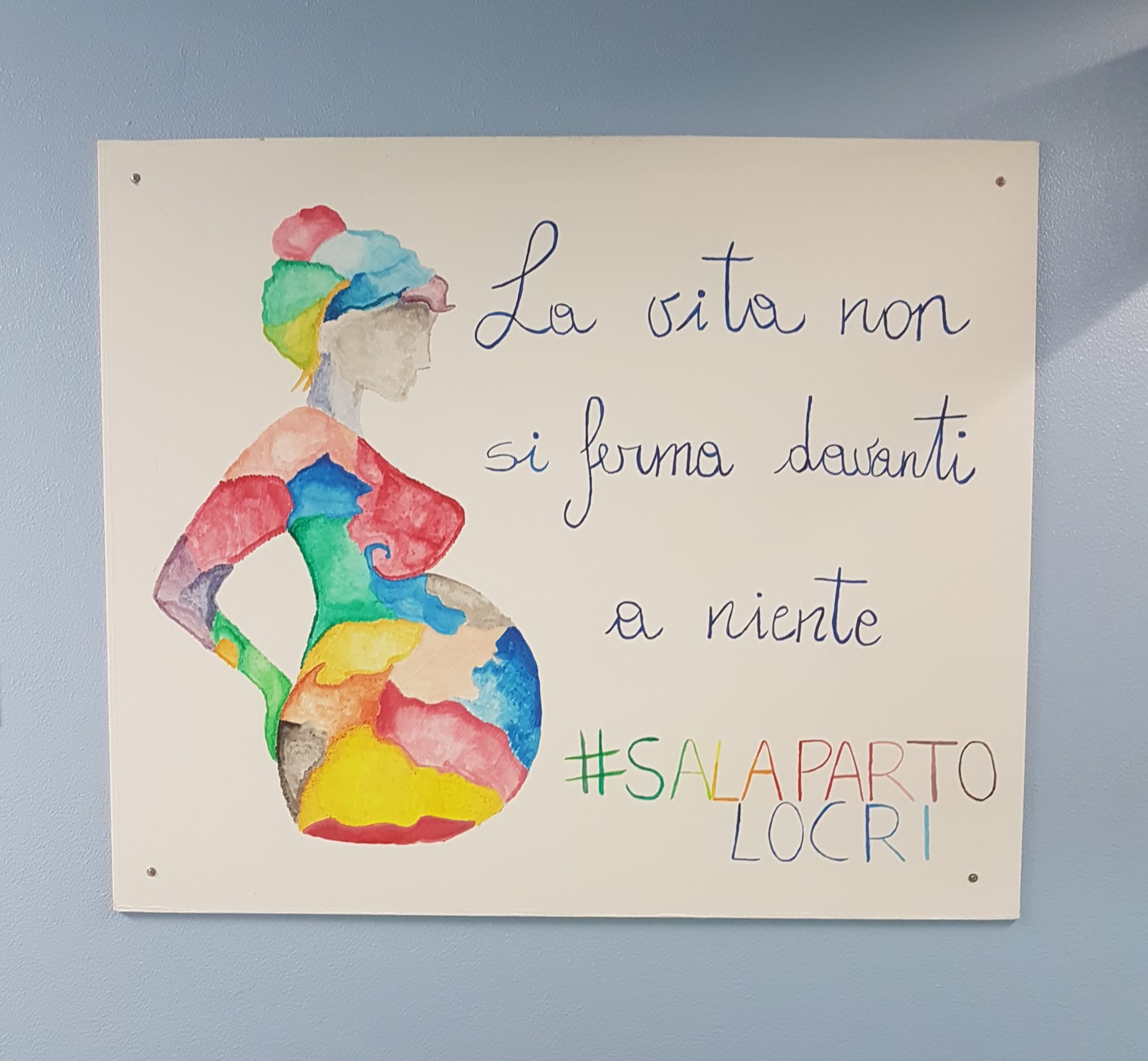di Francesco Tuccio
CAULONIA – Ignari della storia addensata su quel fazzoletto di impiantito sconnesso, dei giovanastri fannulloni, che i genitori non l’avevano certo educati al rispetto ed alla buona creanza, rovistavano puntualmente ogni pomeriggio, con le pance vuote e i piedi nudi, tra i calcinacci di muri diroccati e riversi, tra pietre, travi, tegole e tavole rifrante, come se dovessero scoprire un tesoro sotterrato. E il tesoro c’era veramente, ma loro, analfabeti e ignoranti, non potevano avere orecchie per ascoltare le vicissitudini, il dolore e le ansie della comunità di cui erano indegni figli che quelle rovine raccontavano essendo stati testimoni attenti nei secoli e secoli passati. Anzi, facevano un gran baccano, litigavano, bestemmiavano, disturbavano la quiete di “lor signori”!
{loadposition articolointerno, rounded}
Si, di “lor signori”, rampolli di due casati di alto lignaggio: i Campisi e ed i Musco. Dei primi non abbiamo notizie certe circa le loro origini, ma i secondi avevano ereditato il titolo di barone da Giovanni Calderon, che a sua volta aveva ricevuto l’investitura direttamente da Alfonso d’Aragona, duca di Calabria e Re di Napoli. La linea maschile dei Calderon ad un certo punto si interruppe rinsecchita ed un tal Domenico Musco sposando donna Antonia, l’ultima e unica erede del casato, si beccò il titolo e, soprattutto, l’augusto potere sugli uomini, gli animali e le terre.
Il palazzo dei Campisi era grande con tanto di stemma posto sul bel portale di granito, ornato da due colonne che davano su piazzetta “Mortida”. Quello dei Musco, addirittura, era enorme con più portali: partiva da piazza “Seggio” e terminava sulla stessa piazzetta “Mortida”. L’unico inconveniente era che entrambi avevano un pezzo, con finestre e balconi ben alti e decorati, che si affacciava sull’indecenza proveniente da quelle rovine.
Un giorno, i giovinastri esagerarono veramente ed il barone Musco del tempo, piuttosto basso, rotondo, sprizzante benessere da tutti i pori, altero con gli occhiali inforcati sul naso ed i baffi folti e lunghi che gli partivano dalle orecchie, fieramente indignato, mandò di corsa il suo servo fedele per convocare a palazzo Don Pasquale Lamanna. Il parroco rispose all’invito impassibile e per nulla intimorito da quel comando intimante e irriguardoso.
Appena l’ebbe davanti, il barone accigliato l’apostrofò con gesti e voce altisonanti: “Signor parroco, questa baraonda e questo turpiloquio indecenti devono finire! Provvedete a scacciare quei miserabili cenciosi! E’ inutile che aspettiate la Cassa Sacra, i soldi per ricostruire la chiesa non vi arriveranno mai; con il vostro consenso o meno, il Municipio sgombrerà quel posto insulso e ne farà una piazzetta, statene certo!”
Don Pasquale, uomo navigato e sanguigno, mantenne a stento il contegno che l’abito talare gli imponeva e rispose calmo, fermo e tagliente: “Chiamate posto insulso la terra consacrata a Dio? E’ una vera bestemmia, un sacrilegio! Non avete ancora imparato la lezione del terremoto: Iddio ci ha voluto punire per i nostri peccati e voi continuate a rimanere sordo e ingrato e ad offenderlo ignobilmente. Iddio ha fatto crollare la sua dimora, ma non la sua sacra effigie perché la vuole più bella di prima!” E traboccante d’orgoglio offeso, dopo aver ripreso fiato, aggiunse parafrasandolo alacramente: “Così sarà, statene certo!” Non diede modo al barone di replicare, chiuse la porta dietro le sue spalle ed imboccò la grande scalinata marmorea che lo riportò in un baleno fuori del palazzo.
Era proprio vero, il 5 febbraio del 1783 alle ore 19,12, sotto un cielo incupito, senza luna, gravido di nubi nere come il carbone per la pioggia che aveva riversato a catenelle per tutta la giornata, nel freddo di quel mese “corto ed amaro”, Castelvetere in preda a violente scosse sismiche si mise a tremare come una foglia per un quarto d’ora. Un grappolo d’uva fitto di acini accatastati si scuoteva, sobbalzava, ondeggiava con gran veemenza, mentre i suoi abitanti come formiche terrorizzate, di qua e di là, fuggivano per i vicoli e la strada principale, l’abbandonavano alla sua tragica sventura. Le quattro porte erano state spalancate e sotto le loro volte la gente con gli occhi fuor dalle orbite, urlante e piangente si addensava, si spingeva, si calpestava nell’impeto di uscire tutti insieme e appena fuori le mura accorgendosi di aver perso nella calca qualche familiare gridava il suo nome e cercava di rientrare controcorrente a quella fiumara in piena. Una gran confusione di grida e di pianti. Pareva che la terra volesse aprirsi in due per inghiottire palazzi, chiese, case, uomini ed animali. Il terremoto fece quasi cento morti, senza guardare in faccia nessuno, nobili ed ignobili, ecclesiastici e laici. A questo terremoto dobbiamo la perdita inestimabile di grande parte del nostro patrimonio. Praticamente cancellò in un attimo l’antica Castrum Vetus medievale con il suo castello normanno, le mura merlate che la cingevano, i bastioni armati di cannoni che in prossimità delle quattro porte la resero inespugnabile. E per tornare al punto della contesa tra il barone ed il parroco, crollò totalmente anche la chiesa di San Zaccaria lasciando intatto l’abside con l’affresco bizantino del Cristo Redentore o Trionfante, la nostra più antica e preziosa testimonianza.
Appena le scosse si diradarono, Don Pasquale si avventurò nella profusione caotica di quell’ammasso di rovine: pezzi di muri rovesciati, travi del tetto e tavole del soffitto accatastate qua e là, tegole sparse ovunque, tanti appigli che gli lacerarono la veste talare. Entrò con il suo abito tutto nero e ne uscì tutto bianco, impastato di polvere asfissiante ed accecante. Riuscì ad arrivare carponi fin sotto l’affresco e guardando verso l’alto nel vuoto dell’abside con grande emozione constatò che il Cristo era ancora lì, davanti al trono con una mano sopra il vangelo e l’altra sollevata nell’atto di predicare alle moltitudini della terra di Palestina. Sulla sinistra stava San Giovanni, il prediletto, come prediletta era l’umanità che si rappresentava nella sua immagine. Sulla destra la Vergine Maria rivolgeva lo sguardo di madre pietosa verso i fedeli per invitarli ad ascoltare il verbo, la divina verità. Rabbrividì, gridando dentro di sé al miracolo; non una scalfittura aveva osato toccarlo, erano appena visibili solo qualche ruga del tempo e la patina lasciata dal fumo delle candele, il segno del fervore del popolo adorante. Riuscì, infine, a recuperare tra i calcinacci i libri della parrocchia dove erano registrate le nascite, le morti, i matrimoni e le usuali annotazioni dei parroci che hanno consentito di conoscere fatti minuziosi della nostra storia che altrimenti sarebbero andati perduti, lasciandoci come funghi dalle radici superficiali e non come alberi radicati nella profondità degli eoni del tempo e delle viscere della terra.
Le non poche chiese dentro e fuori la città erano state costruite dai nobili, oppure con il loro contributo ed in ogni caso godevano della loro protezione, sostanziata in donazioni di terre, altari, calici, teche, pulpiti, confessionali, arredi sacri. E nelle chiese dimoravano nell’eterno, aulico sonno coperto da lapidi e mausolei, mentre gli ignobili finivano disperati nelle fosse comuni senza nome, perché nulla erano stati in vita. Sicché, erano frutti del potere, legate al potere nel governo delle anime, tenerle buone e quiete al rango servile, rassegnate sotto il giogo dei potenti. La chiesa di San Zaccaria, invece, simboleggiava le fondamenta del cristianesimo: la conversione. Frutto della conversione di un ebreo, di un tal Simone che volle suggellare la forza salvifica della fede con la costruzione del tempio al Cristo Redentore nella zona del paese che fu il ghetto degli israeliti e dai quali prese il nome di “Judeca”.
Messa così, una banale piazzetta valeva bene la distruzione di secoli di storia e del valore più alto e primordiale della fede. E fu proprio il Cristo, questa volta Trionfante, ad esigere la vittoria su quei nobilastri boriosi, rozzi, ignoranti, con le pance gonfie, piene del sangue dei contadini, dei braccianti e di quei giovinastri fannulloni e screanzati. Suggerì a Don Pasquale di metter mano a quel gruzzoletto di ducati, accumulato con tanta cura e solerzia, per ricostruire la sua chiesa.
Un pomeriggio dell’aprile del 1789, tiepido, assolato, mentre le rondini volteggiavano nel cielo limpido, indaffarate a costruire i loro nidi cretosi sotto balconi e cornicioni, ed i passerotti entravano ed uscivano dai buchi delle case con fili di paglia nel becco, la “Judeca”, i “tamarri” si radunarono attorno alla chiesa di San Zaccaria. Il raduno diventò presto calca umana addensata dentro e fuori il portale, nessuno riusciva a scorgere la punta dei propri piedi. Don Pasquale Lamanna, solenne come un Arcangelo dalla spada infuocata, celebrava la messa dall’altare sottostante al Cristo che aveva abbandonato il suo sguardo profondo, penetrante ed ammonitore per sorridere dolcemente. Le preghiere per un buon raccolto e per essere risparmiati dalle sventure salirono di nuovo al cielo più intense che mai, il dolore per i morti si mescolò al ringraziamento per essere stati risparmiati dal terremoto.
I nostri nobili fecero sbarrare balconi e finestre e stendere le tende suntuose di seta, non un filo di luce riusciva a filtrare nelle tenebre delle loro anime innichilite, non volevano né vedere né sentire, si rannicchiarono al buio come topi intimoriti nelle stanze decorate da stucchi dorati, da figure pagane affrescate, da mobili pregiati; sentirono il loro prestigio vacillare così umiliati e derisi da quel vociare di popolo rinsaldato nel malcontento, nel rancore e persino nell’odio nei loro confronti. Sentimenti e ferite aperte accumulatosi nei secoli.
Poco più di cent’anni dopo, il 23 giugno del 1908, tornò il terremoto e l’edicola del Cristo rimase ancora intatta. Si ricostruì di nuovo la chiesa in legno, poi la mano dell’uomo verso il 1960 la demolì definitivamente e collocò sopra l’edicola una misera tettoia ed un cancelletto alla base per farne luogo frequentatissimo dalle galline e dai gatti in amore. Il tutto nella nostra più totale indifferenza, peggiore di quelle dei Campisi e Musco assommate.
Ora, il rimpallo tra autorità più cieche d’una talpa, l’ha ben sistemato nell’obbrobrio d’una tettoia trasparente, rigorosamente in vetro per accelerare la calura estiva, e tra travi in ferro, tinte dal meraviglioso colore grigio dell’antiruggine. Un moderno capanno che per parcheggiare la macchina nel vostro giardino non l’avreste mai costruito. Nessuno, però, vede i colori smunti, consumati, le figure regredite nell’impatto con l’atmosfera ed il tempo. Il Cristo, forse ha mille anni o forse sta per compierli, ha tempo per aspettare paziente il ritorno di Don Pasquale Lamanna e riprendere gli antichi splendori. E, intanto, la sua mano alzata ci addita alla pubblica vergogna.