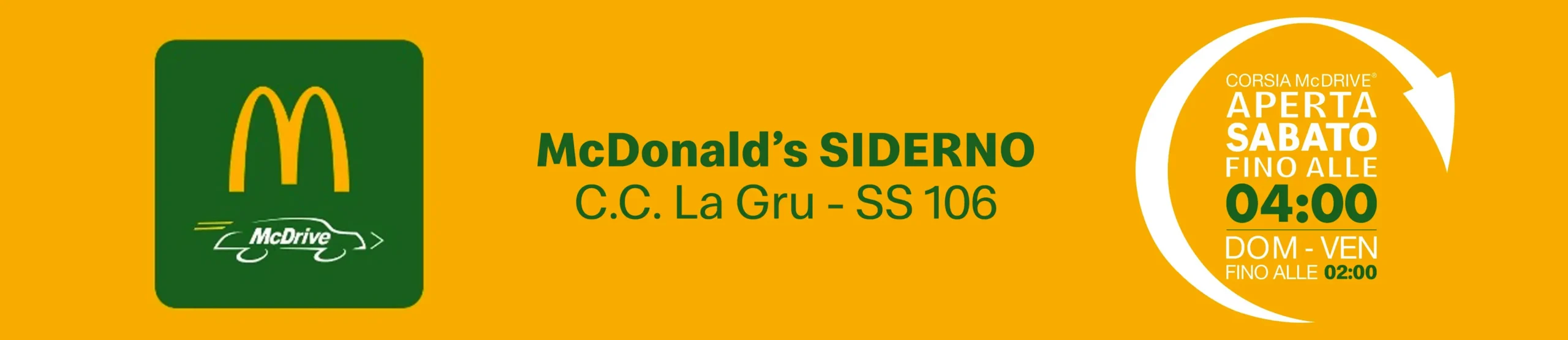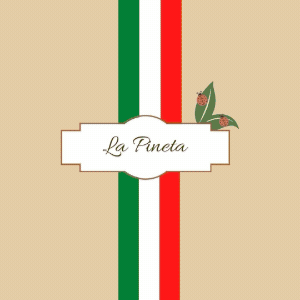*di Mario Staglianò
Recentemente i mezzi di informazione hanno sottolineato la necessità del bonus psicologo per arginare le conseguenze sociali ed economiche delle catastrofi degli ultimi anni.
Le indagini condotte dagli istituti di statistica continuano a denunciare una situazione di emergenza, delineando una preoccupante mancanza di fiducia nelle prospettive a livello nazionale, dovuta ai conflitti globali, alle epidemie, all’incremento del costo della vita, all’iniqua distribuzione della ricchezza e ai cambiamenti climatici.
Circa la metà della platea degli intervistati dichiara di vivere in uno stato di esclusione o di marginalità sociale, con un forte incremento della percezione di disagio rispetto a quanto emerso nelle rilevazioni precedenti.
Il nostro tempo sembra segnato dalla paura del futuro e dall’assenza di prospettive concrete di miglioramento.
È, quindi, significativo che si ritenga necessario porre rimedio a un male sociale con una cura individuale.
Dietro questa forma di intervento ci sembra di scorgere una tacita rassegnazione: “il mondo non cambia, va a rotoli, ma almeno prova a tenere sotto controllo la tua salute mentale”.
Torneremo alla fine a questa industria terapeutica.
Da molto tempo con sempre maggiore frequenza assistiamo al successo delle culture wars, ovvero degli scontri che segnano ormai costantemente la vita intellettuale e militante, amplificati a dismisura dai media e dai partiti politici, fino a diventare laboratorio per la costruzione di una cornice morale del nostro presente, espressione dell’indirizzo ideologico di un settore della popolazione occidentale.
Le forze di destra hanno raccolto frutti importanti da queste contrapposizioni spingendo diversi simulacri – cancel culture, politically correct, woke o fantomatiche “teorie del gender” – nell’alveo della tradizione marxista.
Hanno, quindi, identificato i medesimi simulacri come riformulazioni etico-culturali di un’ideologia sconfitta sul piano economico-politico o come sementi culturali che covavano sotto il barbone di Marx.
In tal modo sono riuscite a spostare la battaglia sul terreno a loro più congeniale creando divisioni nette fra opposti schieramenti: grazie a queste manovre, la società non appare più un corpo regolato da rapporti economici o da meccanismi di sfruttamento del lavoro ma come un terreno di conquista per un potere concentrato su simboli e identità, impegnato ad affermare gerarchie etico-linguistico-culturali utili a definire e governare il reale.
Le conseguenze più corpose di queste trasformazioni si riassumono in una prevalenza delle questioni etiche su quelle politiche, connessa a una concentrazione spasmodica sull’io e sui vincoli che impediscono la sua piena affermazione.
La radicalizzazione delle teorie progressiste si accompagna a un calo progressivo della loro applicabilità, prestandosi quasi esclusivamente a un regolamento di conti circoscritto all’ambito delle elaborazioni intellettuali.
Si promuovono quindi – ed è comprensibile, oltre che prevedibile – campagne antirazziste per combattere il razzismo, interventi di educazione affettiva per combattere il patriarcato o le discriminazioni sessuali ma solo in rarissimi casi si mettono in discussione i meccanismi di subordinazione materiale che alimentano quei fenomeni.
La politicizzazione di molteplici conflitti culturali si accompagna, in definitiva, a una paradossale depoliticizzazione dell’economia accettata come meccanismo fatale e insostituibile, in alcuni casi addirittura “naturalizzata”.
L’attivismo si coagula intorno a immagini evocative o parole d’ordine, fondate sulla condivisione (reale o immaginata) di ascendenze etniche, orientamenti sessuali, abitudini alimentari, sensibilità linguistiche, pensieri per l’ambiente o per gli animali.
Pur avendo un’importanza enorme questi temi riescono, talvolta, a oscurare il ruolo che le persone coprono all’interno del sistema produttivo in qualità di detentrici di forza lavoro.
Questo spostamento di focus favorisce l’insorgere di divisioni molteplici, spesso difficilissime da sanare.
Per quanto screziati e animati da un impeto disgregatore, questi atteggiamenti trovano un punto di incontro in una posizione ideologica chiara che esclude categoricamente lo sbocco rivoluzionario: non esiste alcuna vera alternativa al capitalismo.
Chi si muove nello spazio della differenza intende contestare la concrezione simbolica del potere o il suo “monologismo” ma solo per ottenere il diritto a una partecipazione paritaria.
Si pone come obiettivo l’inclusione o il riconoscimento sociale dei “marginali”, tenendo fuori dal tavolo tutte le ipotesi di rovesciamento o cambiamento del sistema.
In estrema sintesi cerca di sviluppare, nell’ambito culturale, trasformazioni che appaiono ormai impossibili nell’ambito economico.
Nel farlo non tiene in considerazione come lo stesso capitalismo riesca a fagocitare le differenze etico-politiche o le dinamiche identitarie, talvolta accettandole, talvolta addirittura promuovendole, col solo scopo di asservirle alle sue logiche.
Per porla in altri termini, il mercato non ha alcun bisogno di opprimere o di omogeneizzare le diverse individualità ma solo di usarle per massimizzare il profitto.
Le culture wars continuano dunque a rimanere disconnesse da istanze politiche trasformative, limitandosi ad abbracciare posizioni riformiste (a volte timidamente riformiste).
Di conseguenza le scalate sociali di alcune individualità provenienti da contesti “marginali” vengono salutate come straordinarie vittorie, come riconoscimenti per intere categorie storicamente escluse.
La retorica dell’apprezzamento si sostituisce, di fatto, a qualsiasi progetto di cambiamento radicale.
Gli stessi concetti relativi alla decolonizzazione non si riferiscono a concrete egemonie politiche o finanziarie che ancora vigono su varie aree del pianeta, ma diventano metafore pedagogiche finalizzate ad agire sulle coscienze per cambiare atteggiamenti e abitudini: si decolonizzano i programmi di studio, i pensieri degli studenti, le canzoni, i film, le serie tv, le opere o i canoni letterari ma solo di rado si spera di poter fare altrettanto con le porzioni di mondo sottoposte al giogo dei dominatori.
Altrettanto significative sono le opposizioni al “classismo” che intervengono sul disprezzo delle fasce sociali più basse senza curarsi, in parecchi casi, degli aspetti strutturali della stratificazione: bisogna smettere di essere “classisti”, ma non eliminare le differenze di classe; bisogna arginare l’odio verso i poveri, ma non cancellare la povertà.
La necessità di un corretto posizionamento culturale diventa l’unico obiettivo raggiungibile per un attivismo che accetta l’immutabilità del sistema.
Equivale un po’ ad ammettere che, non potendo cambiare il mondo o alterare il funzionamento delle sue forze motrici, tutti gli sforzi debbano orientarsi verso una definizione della realtà sociale capace di escludere le tensioni discriminatorie.
L’orizzonte della lotta si realizza nello spazio dell’iniziativa personale, della “controcondotta”, della scelta etica.
I temi che attraggono il bisogno di contestazione finiscono per privatizzarsi, scivolando all’interno della vita quotidiana, perdendo così la loro proiezione sulla collettività.
E proprio per sviluppare un’indagine su questo versante, diventa cruciale il fenomeno descritto in apertura di questo articolo ovvero la salvaguardia dell’equilibrio psicologico di fronte a uno scenario politico-economico che appare statico, impossibile da scalfire.
A contare non è il funzionamento della società ma la reazione emotiva dell’individuo alle sue fatali storture.
Si affronta l’atrocità dell’esistente con un pacifico senso di rassegnazione, veicolando le energie verso l’affinamento delle tecniche di controllo del sé o verso una salvezza individuale che passa attraverso scelte virtuose.
A trarne beneficio è l’industria terapeutica che è chiamata a ricreare condizioni di benessere per singole persone.
Nell’intimità si trova l’unica possibile compensazione per il fallimento della collettività.
Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalle guerre culturali?
Si può concepire l’idea di rinnegarle o di etichettarle come controproducenti?
La via di uscita si trova nell’adozione di un punto di vista nuovo o nella scelta di una strada non percorsa negli ultimi decenni.
La priorità è osservare il sistema nella sua interezza, comprendendo come le condizioni di vita, le modalità dell’oppressione e i relativi sintomi culturali e ideologici, siano connessi al funzionamento materiale del sistema produttivo.
Accettando questi presupposti, la wokeness – che si riferisce, è utile ricordarlo, allo “stare all’erta”, al “non abbassare la guardia” – può convogliare le sue energie verso un progetto unitario di cambiamento.
Può disinnescare il meccanismo competitivo che indebolisce le identità subalterne, impegnandole nella ricerca di traguardi parziali o particolaristici.
Può connettere su un unico piano di azione le soggettività sociali che hanno operato finora in una funzione solo in apparenza laterale.
Può ricordare a quelle stesse “soggettività sociali” che il vero risveglio passa attraverso una battaglia comune per porre fine alle dinamiche dello sfruttamento.