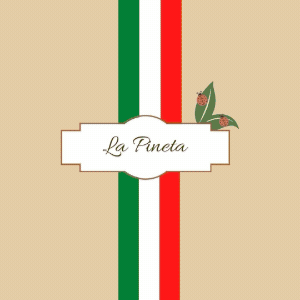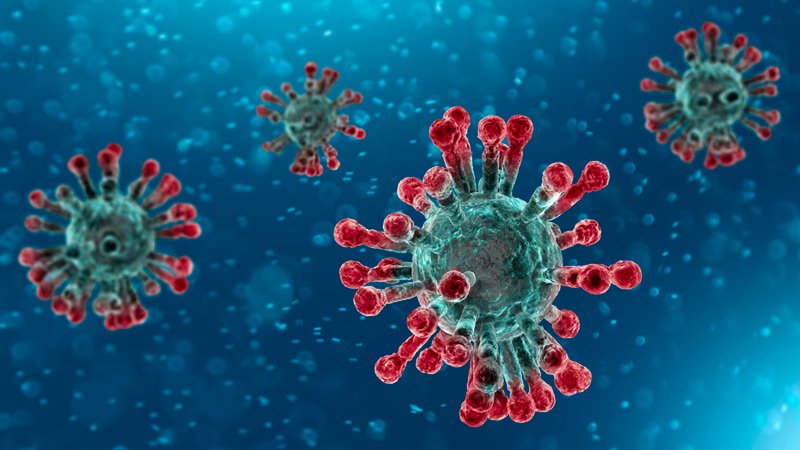(ph.Giuseppe Briglia)
di Francesco Tuccio
Meglio chiamarla Filomena. Un nome, oggigiorno, abbastanza desueto, e perciò più adatto a nascondere all’indiscrezione una persona realmente esistita.
{loadposition articolointerno, rounded}
Era bella? Difficile dirlo: bello è ciò che piace, e Filomena ebbe i suoi corteggiatori di buona famiglia come la sua, quando l’appartenenza sociale era ancora delimitata dagli irti steccati della conservazione. Aveva un viso fresco e naturale, snodato nel profilo delicato, incorniciato nei capelli castani lunghi fino agli omeri; vestiva con decorosa eleganza senza sfoggiare abiti attillati, orecchini e collane appariscenti; neanche un filo di rossetto sulle labbra o di matita sulle ciglia, né di ombretto sulle palpebre che avrebbero potuto renderla più attraente e desiderabile delle sue coetanee. Era evidente che il modo con cui manifestava la sua persona obbediva ad un sentimento alto, ad una volontà interiore ferrigna, ad una vereconda supremazia dello spirito sul corpo e le sue sembianze effimere e peccaminose di cui facevano parte, finanche, lo sguardo e la voce.
In Italia avveniva quella tumultuosa rivoluzione del costume a cavallo degli anni ‘60 e ’70, e a Caulonia si sentivano i benefici effetti liberatori. Le ragazze accorciavano la gonna, indossavano i blu jeans e si incontravano per amoreggiare con i ragazzi a piazzetta Bellavista, a quella del Municipio ed i più arditi s’avventuravano a passeggiare sulla provinciale fino alla seconda curva a gomito per rubare qualche brivido, qualche sfioratura di mani, qualche bacio appena accennato, mentre il cuore batteva più forte per il timore di essere visti. Sentimenti arditi delle nuove generazioni, che avevano bucato la coltre ispessita da un lungo passato, e che germogliavano fragili, furtivi e platonici.
Ma per Filomena erano rimasti i luoghi tradizionali dove erano nati gli amori di tutti gli eoni del tempo. Si poteva solo sperare di incrociare il suo sguardo sereno e profondo mentre si recava in chiesa, durante le funzioni religiose, nelle processioni, sempre con quella sua veletta ricamata, candida e trasparente, appuntata sulla chioma fluente con uno spillo dorato. Ai saluti riverenti e galanti rispondeva per buona educazione, timida e risoluta a far cadere ogni più ardente speranza. Difficilmente incrociava lo stesso sguardo per due volte. Il padre era stato sempre costretto a declinare, con imbarazzo e garbo, ogni domanda di matrimonio pur conveniente ed adeguata alla sua posizione sociale. Lei, invece, aveva già scelto lo sposo prediletto che non avrebbe mai tradito e, forse, vestendo il cilicio avrebbe castigato il corpo, i sensi e i pensieri irrefrenabili e sfuggenti per giungere al dolore, e attraverso il dolore a quell’unione assoluta, estatica e duratura per questa e l’altra vita, nelle tenebre luminose della clausura. Buona, amorevole ed ubbidiente com’era, non avrebbe mai potuto straziare il cuore dell’anziana madre che, avendo già perso l’unico figlio maschio nel fiore dell’adolescenza, non voleva, ostinatamente, saperla rilegata in qualche chiostro, sacrificata nella solitudine di qualche misera cella lontana da casa, ignorata e nascosta alle gioie e ai dolori del mondo.
La settimana santa a Caulonia ha confitte le radici nella notte dei tempi e ne conserva ancora l’impronta aulica dell’epoca dello spagnolismo. Dalla domenica delle Palme, alla domenica di Pasqua è un intenso susseguo di processioni che celebrano il dramma della passione di Cristo con grande, sentita partecipazione di popolo. Ricorrono giorni straordinari di fede che non hanno eguali in tutto il mondo cristiano. E in uno di quegli anni, come ogni anno da tempi immemori, giunse un predicatore, un giovane frate francescano che aveva stampato nella figura esile e scarna, nella tonica pieghettata molle e fluttuante, nei sandali polverosi quell’amore fraterno ed ascetico per il Creatore e il creato del padre fondatore del suo ordine.
La Matrice era colma fino all’inverosimile sotto le alte navate, con gli stucchi e gli ori resi scintillanti dal lume delle candele, dalle luci dell’altare e delle volte del colonnato che avvolgevano e sovrastavano il popolo eletto. La moltitudine ansiosa e sbalordita era rapita dalle parole che provenivano dal pulpito elevato, sorretto da una grande aquila dalle ali tese che pareva volesse aleggiare in cielo il predicatore per far giungere in terra la parola divina.
Il frate con mano espressiva e voce ferma compiva una disamina profonda delle colpe più recondite, si soffermava nella tenebrosa e cruda descrizione dei castighi, vibrava strali ed anatemi contro i peccati ed i peccatori. Poi, con toni ora elevati ed ora sommessi, con tocco lieve e carezzevole, affondava nella passione: dall’orto del monte degli ulivi del calice amaro offerto al Dio fatto uomo, alla flagellazione e coronazione di spine, al giudizio umiliante dell’Ecce Homo al cospetto della turba sorda, ingrata e violenta, alle spalle barcollanti e cadenti sotto il peso del legno duro della condanna, fino alla crocifissione lancinante, all’agonia ed alle tenebre squarciate dalle folgori, alla luce abbagliante e soave della resurrezione. Scavava nei cuori induriti, scuoteva le corde della trepidazione, le fibre e i recessi più intimi dell’anima; elevava nelle visioni del Getsémani, della corte ostile di Pilato e dei sommi sacerdoti; trascinava nel sole rovente per le vie e le piazze di Gerusalemme, ed in un crescendo doloroso, in un requiem tragico, solenne, aulico saliva al Golgota per deporre dolcemente ai piedi della Croce quelle anime lacrimanti, estasiate e traboccanti di sospiri d’amore; infine, le librava nel tripudio del cielo terso e del sole splendente di Pasqua nato dal grembo della notte per suggellare l’apoteosi della vittoria del divino sul profano, del bene sul male, della verità sulla menzogna, della vita eterna sulla morte.
Il frate si sporgeva sulla folla come trasfigurato nei gesti accorati e frementi, con la testa tonsurata, la barba da cappuccino, le mani ed il viso pallidi della penitenza, gli occhi accesi dalla fede e dalle visioni celestiali; si sentiva in perfetta comunione con gli astanti ammutoliti e contriti, con le labbra che pendevano dalle sue labbra eloquenti, con gli occhi rapiti nei suoi occhi di fuoco, con i cuori che palpitavano tempestosi all’unisono con il suo.
Le note grevi e melodiose dell’organo si levavano in un inno di gloria che travalicava i vetri colorati della chiesa, scendeva la tromba stretta delle scale del campanile, si perdeva nella piazza e nelle ombre allungate della sera, mentre i “fratelli” in camice e cappuccio bianchi, con i cingoli e le mantelline corte dal colore della propria confraternita, il celeste dell’Immacolata ed il nero dell’Addolorata, con le croci tese in alto, poggiate nelle cinghie di cuoio ad armacollo, con i ceri accesi s’incamminavano cantando nella “gira” seguiti dai sacerdoti vestiti con il gran sfarzo dei paramenti liturgici e l’aureola dell’ostensorio dorato del santissimo Sacramento a cui si inchinavano prostrate due ali di folla.
La comunità placata, inebriata dal profumo dell’incenso, si sciolse, e ognuno tornò a cassa sollevato, rinato, mondato dalle proprie miserie, ma Filomena rimase in piedi, e ferma cercò con occhi imploranti il frate, ardeva dal desiderio di confessarsi. Si accostò alla grata del confessionale con il petto in tumulto e la gola e le labbra arse, e sitibonda emise un filo di voce calda.
Parlò con lui dell’amore divino, delle colpe e delle perdizioni, delle blandizie del mondo, delle lunghe notti angosciose trascorse sul suo letto verginale, dove febbricitante combatteva le tentazioni carnali dei demoni delle profondità abissali insinuati nei meandri della mente. Aprì del tutto il suo cuore come non l’avrebbe mai fatto con sé stessa ai piedi del Crocefisso muto e compassionevole, della Vergine splendente di fiammelle tremolanti. Cercava il confessore, e sentì l’uomo e il confidente trasalire nel pallore e nel rossore del medesimo vissuto, nelle stesse inquietudini dolorose, negli stessi pensieri fustigati. Si sentì con lui, si confuse in lui, si immedesimò dolcemente nelle crepe di una umanità fragile e forte nell’aspirazione trascendentale, nel conflitto eterno con sé stessi, con l’essere, con il sentire ancestrale. S’impose il vincolo indissolubile suggellato dall’abito sacro, fu sorretta e consolata in quell’abbraccio carezzevole che la rendeva più pura, in quell’amplesso sublime che la lasciava vergine e casta, nel mistero, nel segreto, nel silenzio mistico della chiesa ormai deserta.
Il frate andò via per sempre, continuando il suo viaggio caritatevole, la sua missione di fede. Filomena l’accompagnò con il pensiero per strade e paesi sconosciuti, sentì risuonare la sua voce in altre chiese, avvertì la sua immagine esile accanto a lei in ogni istante di vita, si accostò sempre all’altare come presa per mano, nella pace sublime delle primavere in fiore, delle stelle splendenti nel firmamento. Lui l’accompagnava per sempre nell’elevazione a Dio.
Già! Cos’è l’amore, qualsiasi amore quando è crogiolo di inquietudini, di gioie e dolori, se non elevazione del sentimento umano.