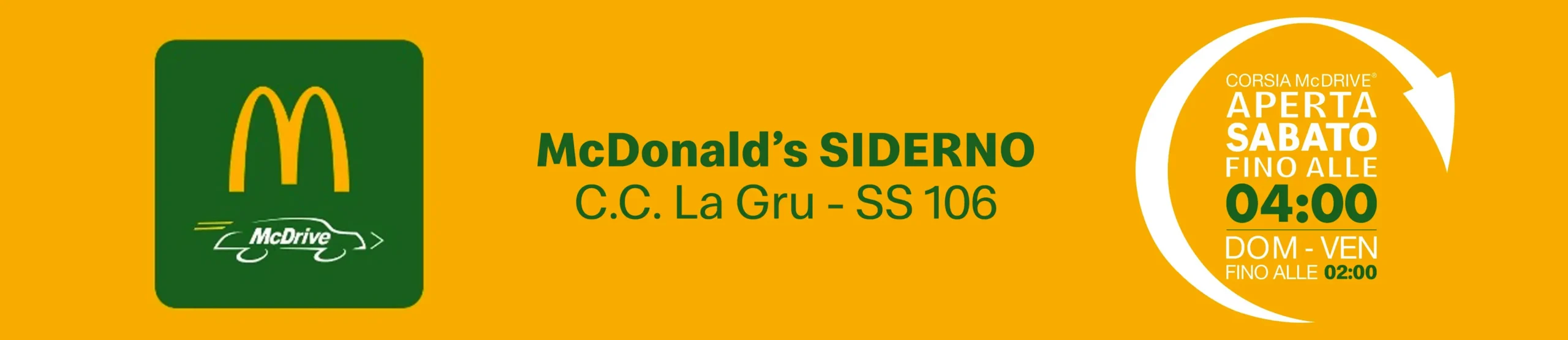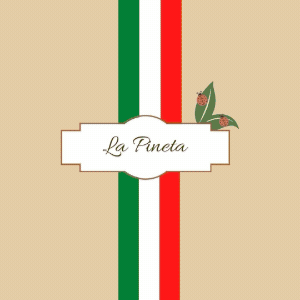di Francesco Tuccio
Come in un mondo avvolto nell’oscura nebulosa dei sensi, lei apparve con lo stupore di un sole splendente, destinato a schiarire le notti agostane della gioventù di quel tempo.
Le fattezze del corpo, turgido ed eburneo delle valchirie, lasciavano presagire le lascivie di taluni velluti di seta nel lucore soffuso tra le pieghe dell’immaginazione; i capelli biondi, tagliati corti alla mascolina, stagliavano le linee delicate del collo, dei lobi morbidi e pendenti, delle gote rosee e fresche della rugiada dei mattini vermigli; le ciglia, arcuate lievi e sottili, seguivano la fronte altera, congiungevano lo snodo del naso dritto, delle prominenze delle labbra tumide, del mento tondo e marcato, e l’insieme dei tratti del profilo del volto formava l’armonia della bellezza scolpita, levigata con le finezze del latte opalescente dell’estro antico, consapevole e lusingata dell’attrazione degli sguardi e dei desideri carnali. Rivelava i segreti delle lontananze delle aspre vette innevate, delle città invivibili distese alle falde di ampie valli montane, dei laghi di profondi cristalli che tralucevano nelle sue pupille con il balenio dei cieli glauchi ed algidi.
{loadposition articolointerno, rounded}
Apparve da una piccola tenda impiantata all’ombra dei pioppi nel camping in riva al mare, e si prese i sogni avventurosi e le ansie, si confisse nei pensieri e nell’anima della fragile e caduca immortalità giovanile. Qualcuno, innamorato al primo sguardo e che aveva letto l’amore sui libri, preso dal vezzo del luogo ad appioppare nomignoli, la chiamò Brunilde e nessuno più si chiese quale fosse il suo nome vero. E avviluppata nel mistero rimase, pure, la sua vita, declamata tutta al presente nell’effluvio effimero di un soffio di vento, di una brezza marina, d’uno stormire di foglie cadenti. Lei si compiacque in quel nome che la proclamava eterea regina di una corte smaniosa.
Brunilde era agile, accogliente ad ogni nuova amicizia che affluiva con la forza dello sciame inebriato dal polline. E fu un’inesausta disfida di sospiri, languori ed inviti galanti ad attendere l’alba sulla riva del mare. Le note delle chitarre, i canti, le danze, il cicaleggio delle parole, dei frizzi scivolavano leggeri sul planisfero di sabbie e ghiaie della spiaggia, cercavano lei soltanto, come le brame assetate nei deserti sterminati e mutevoli, e muovevano incessanti alle faville crepitanti dei falò che risalivano con lingue di fuoco nei briosi cieli notturni stellati, ispirando l’amore invaghito nelle immensità romantiche, nei recessi viscerali della natura, nelle chiome arruffate e vuote. Lei parlava con voce di porpora suadente, sottile e tagliente, incrociava gli sguardi di tutti e non vedeva nessuno, e tutti annegò nelle fauci del drago delle allucinazioni. Libellule per una notte, cominciarono a viaggiare nei meandri dei panorami densi delle rose dei fumi; volteggiavano nei paradisi, nella summa di tutte le meraviglie con il brusio dei cirri delle spume saline, acri e pungenti come gli inganni dei pleniluni senza uno sputo di luce.
Le rifrangenze settembrine dello scirocco dilavò le orme incavate e i tizzoni spenti, ricacciò Brunilde nelle sue città diacce e remote e lasciò infrante le vite della felicità visionaria e illusoria, iniziate alle utopie dalla voragine delle droghe. Tutto rimase dissolto nel vuoto dell’angoscia, della disperazione che invocava Brunilde, e con Brunilde smarrirono il senso di sé.
E Brunilde tornò innumerevoli anni dopo. Apparve, sorretta dai figli, terrena e sporca. Nessuna traccia della bellezza trascorsa, avvolta nel sudario del disfacimento. Del mare. della spiaggia, della canicola di quei soli, del pallore della luna e del gorgoglio delle stelle non tratteneva più la memoria, e trasfigurata dal veleno che la divorava dentro, gesticolava, nell’aria ammorbata, con le mani raggrinzite e scarne tese alla ricerca delle ombre di un vago rimorso. Parlava concitata, furente con il nemico bieco rintanato nella sua mente.