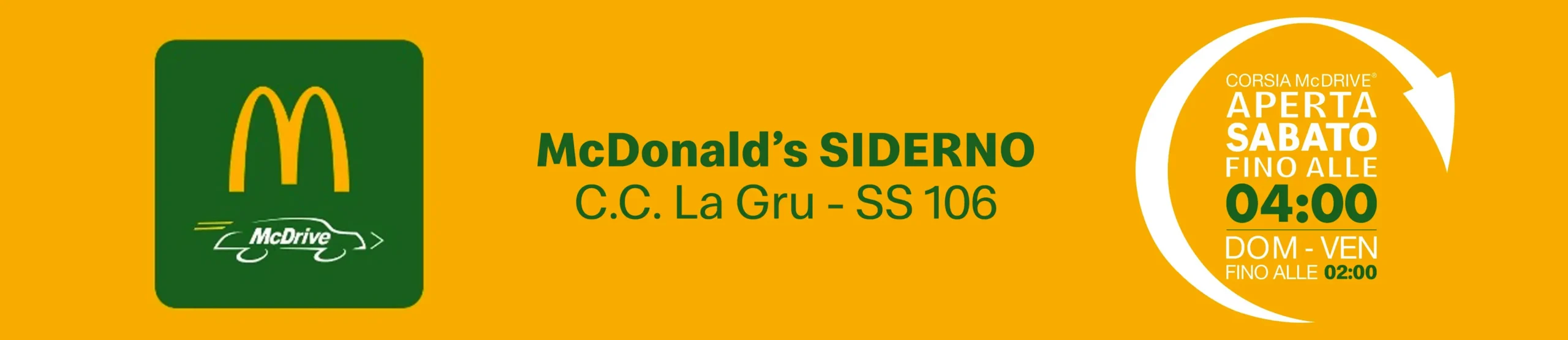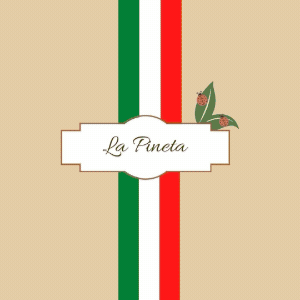di Francesco Tuccio (dipinto in home page di Francesco Gallo e foto interna di Giuseppe Lamberto)
CAULONIA – Il castello è il luogo dove maggiormente indugia la fantasia nell’ascolto delle pietre scalfite dai rumori silenti della storia. Il nostro ha una data di nascita incerta. In un documento del 1050, nel descrivere i confini del monastero di S. Quirico d’Amusa ricorre il termine “palaiokastron” (fortificazione sommitale – kastron città fortificata) che rinvia all’epoca bizantina.
{loadposition articolointerno, rounded}
Sicuramente, del Castellum Vetus che diede il nome a Castelvetere i normanni ne fecero una fortezza inespugnabile, radicato come’era sull’escrescenza rupestre elevata da una cima collinare a cavallo della confluenza di due vallate, l’Allaro e l’Amusa. Da quell’altura vorticosa protesa al cielo difendeva la rocca della città e da essa si isolava ritraendo il ponte levatoio nell’ultima estrema resistenza ai nemici assalitori, ai saraceni, ai turchi, ai senza Dio. Esattamente 221 anni fa, nei primi giorni di quel febbraio piovoso, freddo e denso di sciagura del 1783, un terribile terremoto cancellò in una sola notte le costruzioni medievali, comprese le massicce mura merlate e i bastioni che cingevano la città. Morirono cento persone, e, con l’ingiustizia connaturata negli eventi tragici naturali, si contarono più vittime tra gli ignobili che tra i nobili, più tra i laici che tra gli ecclesiastici. Del castello non rimasero che pochi resti a perenne memoria.
Noi, generazioni del dopoguerra, potevamo guardare solo da lontano le strette cigliate della timpa, dove le lucertole amoreggiavano crogiolandosi al sole e la notte spuntavano le salamandre per argentarsi al lume della luna. Là, crescevano le more di rovo, i sambuchi e le erbe erratiche, e si diffondevano per i fianchi del dirupo il giallo delle ginestre, il salto dei grilli, il volo ronzante delle api, delle vespe e dei calabroni intenti a posarsi sulle corolle dei petali per inseminare e succhiare il polline.
Dalle stesse ripide pendici, a mo’ di contrafforti, prorompevano i ruderi dei bastioni che, vetusti e dritti come una candela, dominavano impettiti le valli con i corsi d’acqua torrenziali orlati dai giardini di zagara, e sfrangiavano il vento gelido di tramontana da più di un millennio. Dai buchi di quei muri si librava il volo delle “ciavole” (cornacchie nere) gracchianti come spiriti aviti che entravano ad inquietare i sogni dei ragazzi, e come presagi di sventura agitavano la mente degli adulti. A stormi inesausti, storie immaginarie di solitari cavalieri di ventura e di regine prigioniere tra mura merlate volteggiavano nell’aria degli echi epici della notte dei tempi, sorvolavano gli orti, gli oliveti e i seminativi lungo i pendii e gli antichi sentieri sino a fondovalle, risalivano leggere nel cielo cerulo verso le nuvole a fiocchi con il canto delle cicale, in un crescendo di vaghi brusii di mare, di sospiri onirici e fanciulleschi.
Tutti volevamo un “patace di ciavola”, un giovane volatile maldestro che si lasciasse cadere dai buchi del mistero, e tutti l’avremmo difeso dal gatto, allevato e addestrato a volare libero per casa con un filo di spago sottile annodato ad una zampetta. Era bizzarra la nostra idea di libertà, tuttavia l’avremmo portato per le strade e le piazze come un trofeo, fieri di destare l’ammirazione e l’invidia dei compagni di gioco. Per questo attendevamo invano per ore ed ore alle falde inaccessibili della timpa con il naso appeso per aria e gli occhi dell’immaginazione a rovistare i nidi.
Poi, negli anni ’60 ci piovve improvvisa la Cassa per il Mezzogiorno che impietosa ci sfigurò il paesaggio e trasfigurò i sogni magici delle favole dell’inconscio fanciullesco in un serbatoio imponente, un fungo di cemento senza buchi, estraneo, ingombrante e dolente come un pugno nell’occhio. Risolveva un problema annoso: un desiderio di civiltà che voleva l’acqua potabile continua nelle case. Fummo felici dell’incapacità di guardare al di là del nostro naso, di non pretendere alternative possibili e più convenienti come gli effetti dei giorni nostri stanno a dimostrare. Il mostro fu costruito accanto all’ampio ombrello di una “pignara” (pino) secolare a voler simboleggiare la vittoria delle scempio moderno sull’antica armonia.
Fra tutti i cauloniesi, un solo uomo, il compianto Francesco Gallo, valente e onesto artigiano, mostrò tutto il suo sdegno per quella ferita inferta alla nostra storia, alle nostre bellezze paesaggistiche e naturali. Lo fece in silenzio con la voce stentorea dell’artista che era, con i suoi pennelli, i suoi colori, i suoi tratti sapienti. Francesco dipinse molti scorci di Caulonia, più volte ritrasse il vasto panorama con in primo piano la rupe del castello, ma la sua sensibilità lo portò sempre ad ignorare il fungo/serbatoio che nei suoi quadri non vi trovò mai posto. Alcuni nostri emigrati hanno nelle loro case sparse per il mondo dei dipinti di Francesco Gallo, li hanno portati con sé per mostrare con viva evidenza l’orgoglio e il legame affettivo con il paese natio che si avvaleva di un indubbio talento artistico.
Anche le “ciavole” si offesero, non tollerarono l’obbrobrio che segnava la fine di un’epoca e ci catapultava nella modernità irriguardosa dei valori antichi, e indignate non ci perdonarono. Compresero la profondità del taglio che aveva spezzato l’intesa misteriosa e onirica con generazioni e generazioni di ragazzi. Quel filo invisibile della fantasia, quel legame con le nostre origini che custodivano gelosamente era stato reciso per sempre e per sempre se ne andarono via gracchiando sdegno. Loro volevano abitare nel luogo del castello incantato e non in quello che divenne, il luogo banale del fungo, il monumento alla più barbara insipienza.
Adesso, se Caulonia riuscirà ad avere politici meno rissosi e più avveduti, il fungo potrebbe avere (non dico mesi) ma due o tre anni contati. L’arsenico ha inquinato irrimediabilmente la falda acquifera di Amusa, ha imposto, speriamo solo, disaggi agli abitanti del centro. Nessuno l’avrebbe voluto e auspicato, ma potrebbe rivelarsi il tipico male giunto non soltanto per nuocere. Il costruendo nuovo acquedotto dalla vecchia sorgiva di Stramerca porterà l’acqua potabile a caduta naturale, risparmiando una spesa cospicua in energia elettrica e rendendo inutile e non più giustificabile l’esistenza del fungo che con il suo peso costituisce sempre una minaccia per la stabilità della rupe. Abbatterlo è una misura di sicurezza e, allo stesso tempo, una importante opportunità. Acquisendo equamente la rimanente area privata si potrebbe costruire una villa pubblica, una piccola struttura museale, una sala conferenze e di proiezione, una struttura turistica/culturale permanente di grande attrattiva per posizione panoramica privilegiata che i castelli hanno sempre goduto. Un opera che potrebbe vivacizzare il centro, ostacolandone il depauperamento degli abitanti e delle piccole attività economiche a cui è vistosamente avviato.
P.S. Ringrazio Luigi Gallo, artista, per avermi inviato la foto di uno dei dipinti panoramici di suo padre.