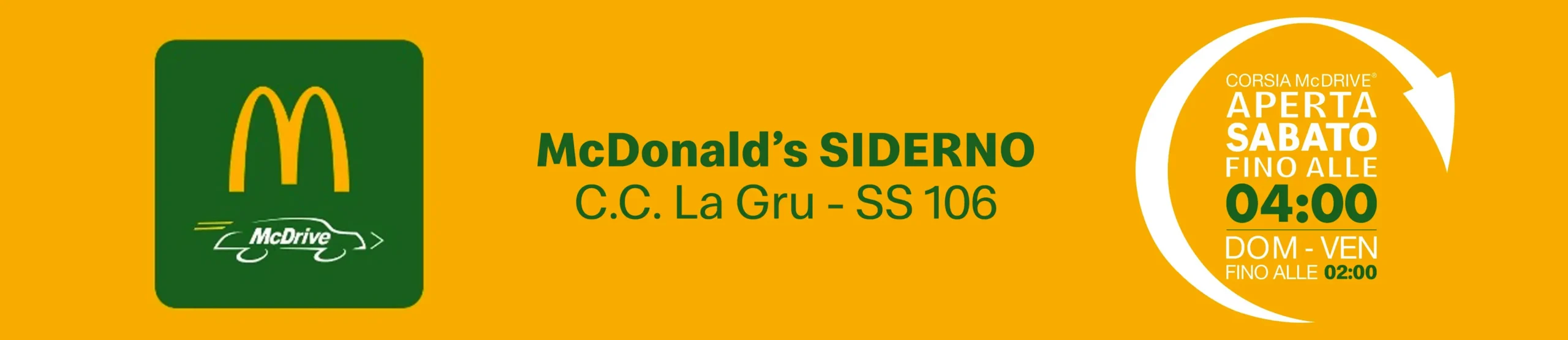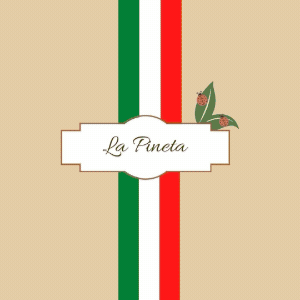di Gianluca Albanese
SIDERNO – Il maxi-processo “Aemilia”, la cui sentenza di primo grado è stata pronunciata ieri, e ha portato alla condanna di 118 imputati accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso nella zona compresa tra le province di Reggio Emilia e Mantova, che fanno capo al boss originario di Cutro Nicolino Grande Aracri, a capo dell’omonima cosca, svela un grande segreto di Pulcinella, che solo un’opinione pubblica distratta e facilona aveva potuto tacere da tempo: la ‘ndrangheta ha messo, da decenni, solide radici nell’Italia settentrionale, laddove è stato facile cogliere quel clima di omertà e di connivenza che solo una certa bibliografia e cinematografia volevano confinare alla Calabria e al Sud Italia in particolare.
Oggi fa notizia la condanna a due anni per l’ex calciatore della Nazionale Vincenzo Iaquinta, che avrebbe lasciato nella disponibilità del padre Giuseppe (condannato a 19 anni di reclusione) un ingente quantitativo di armi e munizioni legalmente detenute, ma il vero dato su cui riflettere è costituito, a nostro avviso, dalla sentenza di condanna scaturita da un’inchiesta avviata all’inizio dell’attuale decennio (e che fa seguito alle analoghe operazioni denominate “Grande drago”, “Edilpiovra”, “Scacco matto” e “Pandora”) basata proprio sulle intercettazioni disposte sui boss come il già citato Nicolino Grande Aracri, detto “manuzza” e che segue l’allarme lanciato dal sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Roberto Pennisi, sancendo l’esistenza della ‘ndrangheta in una parte d’Italia troppo frettolosamente definita immune dalla presenza mafiosa, se non un vero e proprio modello di buona amministrazione.
La storia della presenza criminale al Nord, infatti, è vecchia di almeno cinquant’anni, con boss e gregari calabresi inviati al soggiorno obbligato: la Direzione Investigativa Antimafia ne ha stimati ben 3.560 tra il 1961 e il 1995. Troppi, per non dare vita alle attività criminali tradizionali, come le estorsioni ai danni d’imprese gestite da corregionali emigrati (i primi a conoscere la pervasività criminale della ‘ndrangheta e i suoi metodi d’intimidazione) e proseguita nel traffico di stupefacenti e nei business classici come l’edilizia, il movimento terra, le bische e i locali d’intrattenimento.
Ovviamente, non c’è solo la ‘ndrangheta di Cutro in Emilia: ci sono i casalesi dei clan Schiavone e Bidognetti, la mafia siciliana – lo stesso boss Tano Badalamenti, che fece uccidere Peppino Impastato, investì nei trasporti a Sassuolo – e gli altri clan calabresi come i Nirta-Strangio di San Luca, i Mancuso di Limbadi, i Bellocco di Rosarno e i Vadalà-Scrivia di Bova.
A proposito di casalesi: qualche anno fa, i camorristi e i loro fiancheggiatori fecero quello che nel Sud Italia non si è mai sentito: un vero e proprio assalto alla caserma dei Carabinieri di Sant’Agata Bolognese dopo l’arresto di un boss che aveva avuto un alterco con un immigrato senegalese, respinto solo dopo qualche ora, con l’arrivo di rinforzi dalle città vicine.
Tra le principali piazze ormai contaminate dalla presenza delle cosche calabresi c’è Reggio Emilia, che conta oltre diecimila abitanti originari di Cutro il cui peso elettorale sposta gli equilibri da una parte o dall’altra, tanto che sono stati numerosi gli amministratori (compreso l’ex ministro Graziano Del Rio) che sono andati a Cutro in occasione della processione del Santissimo Crocifisso, particolarmente importante per tutta la comunità cutrese, compresi i boss e i picciotti.
Brescello, poi, sempre in provincia di Reggio Emilia, e nota per essere stato il paese dei film con protagonisti don Camillo e il sindaco comunista Peppone, è stata la sede del primo consiglio comunale sciolto per infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna. E’ il paese in cui risiede e conduce le proprie attività imprenditoriali Francesco Grande Aracri, fratello del boss Nicolino e nel quale il clima di omertà che regnava venne documentato nell’inchiesta giornalistica “Cortocircuito”, realizzata dagli studenti liceali e universitari di Reggio Emilia e successivamente acquisita nelle carte dell’operazione “Aemilia”.
A contribuire a scoperchiare il vaso di Pandora della presenza criminale nella regione “rossa” per antonomasia, fu soprattutto un bravo poliziotto: Fabio Bernardi, che nel 2008 venne nominato capo della Squadra Mobile della Questura di Bologna che dopo il suo arrivo, fece alcune scelte di buonsenso, prima tra tutte il coordinamento tra i vari settori di attività della Polizia, e puntò dritto contro le cosche in Emilia. Dopo quattro anni d’intensa attività investigativa, venne trasferito all’Interpol, senza ricevere alcuna onorificenza pubblica. In compenso, negli ultimissimi giorni di permanenza a Bologna, ignoti cosparsero di escrementi umani il parabrezza della sua autovettura, parcheggiata sotto l’appartamento di servizio, a due passi dalla stazione centrale.
Per saperne di più su questi fenomeni, suggeriamo la lettura di due saggi illuminanti: “Tra la via Emilia e il clan” (2010, Casa della Legalità di Genova) di Antonio Amorosi e Christian Abbondanza, e “Coop connection” (2016, Chiarelettere) di Antonio Amorosi, oltre al testo ritratto nella foto: “Ndrangheta totalitaria” (2017, Falco editore) di Andrea Carnì.